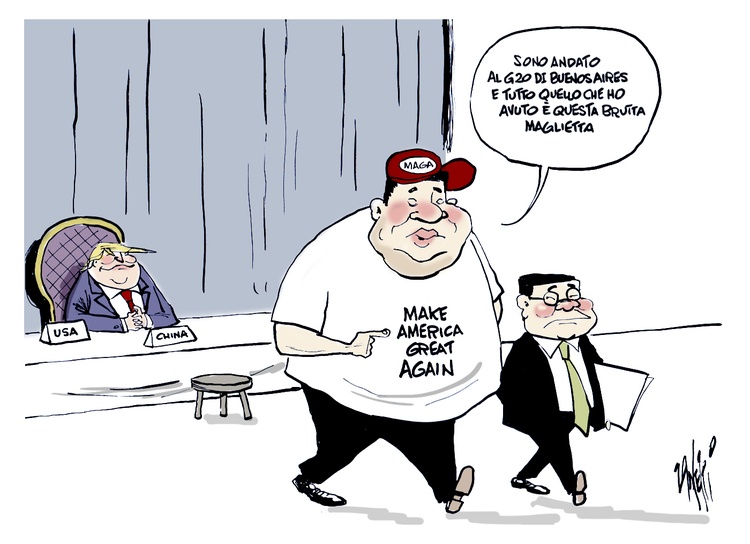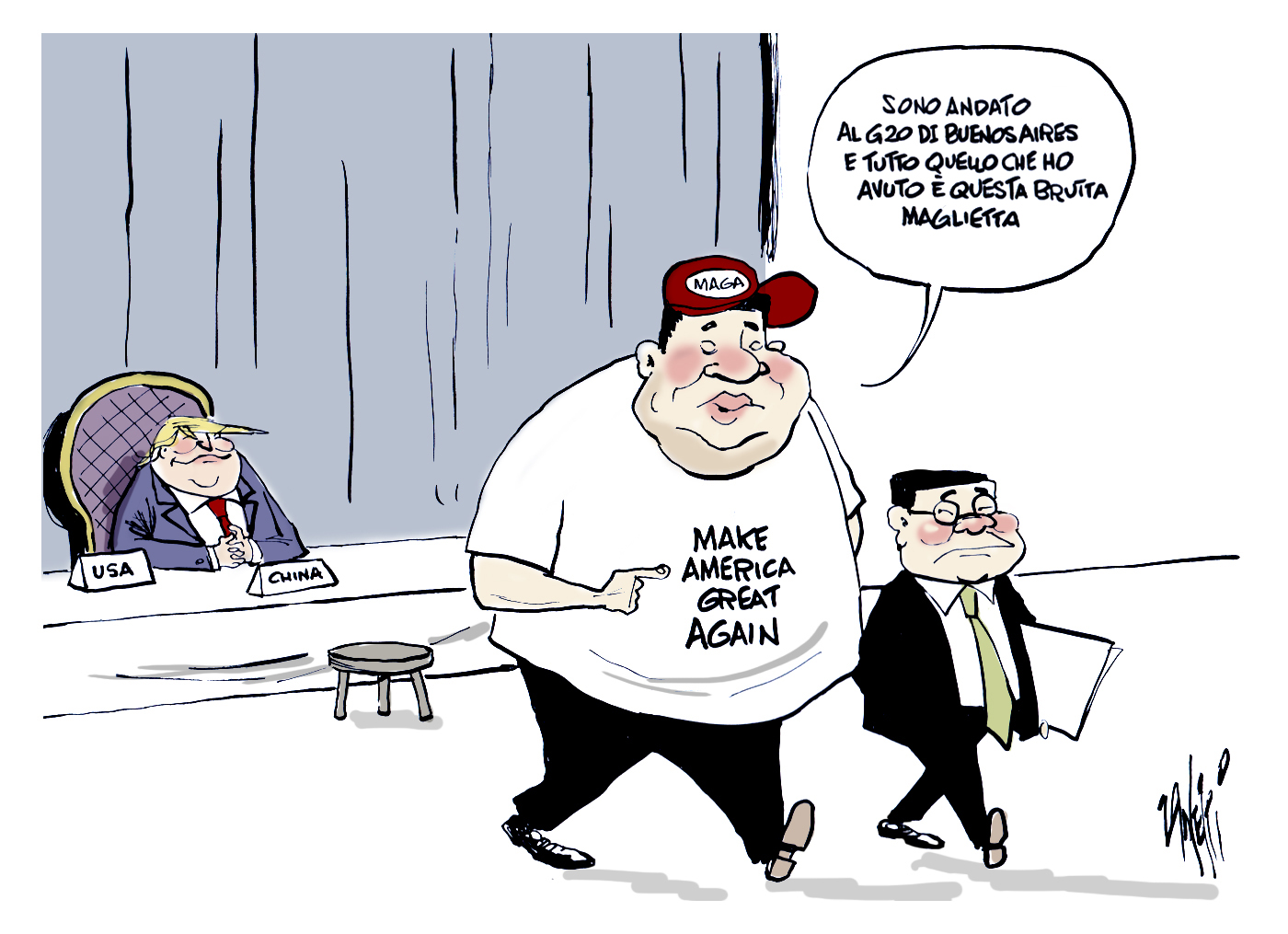Uno dei momenti iconograficamente più simbolici della storia del Partito liberale di questi ultimi mesi è rappresentato da un doppio fotogramma: da una parte il primo ministro Scott Morrison e il titolare del dicastero del Tesoro Josh Frydenberg che, anticipando il budget ad aprile e confermando l’aggiornamento economico per il 17 dicembre, cercano di tenere la barra dritta sui punti di forza del governo in carica; dall’altra, a pochi metri di distanza quasi in contemporanea, Julia Banks che rassegna le proprie dimissioni dal Partito, a quanto pare all’insaputa del primo ministro.
Due immagini contrastanti che tuttavia sembrano essere legate da un minimo comune denominatore: il caos dentro il Partito liberale che alcuni osservatori come Chris Kenny dalle colonne del ‘The Australian’, ritengono sia causato, almeno a livello federale, dalla corte dei cosiddetti liberali moderati guidati da Malcolm Turnbull.
Una situazione che evidentemente innervosisce molto il primo ministro che invece prova a riportare, non senza, va detto, una certa confusione, l’attenzione sulla sua agenda politica. Ma è proprio questo il tema centrale: l’offerta politica del governo Morrison non è mai stata chiara, non è mai stata esplicitata e, quando è accaduto, è stato fatto in maniera, appunto, caotica e improvvisata.
Per non parlare dei grossolani errori di valutazione politica, uno per tutti, la proposta dello spostamento dell’ambasciata australiana a Gerusalemme, che abbiamo avuto modo di approfondire in maniera alquanto esaustiva sulle pagine di questo giornale e che, secondo quanto emerso dall’audizione in Senato, sarebbe stata presa senza avere consultato preventivamente il competente ministero degli Affari Esteri e senza aver rispettato gli standard procedurali relativi alla sicurezza nazionale.
Mancano ormai poco più di sei mesi al voto federale e i segnali che arrivano agli elettori da Canberra dalla coalizione di governo non sono certamente dei più edificanti, non ultima la scelta di calendarizzare solo nove giorni di lavori parlamentari per il 2019. Scelta legittima, per un governo chiaramente in minoranza che, come accaduto con la Banks, continua anche a perdere pezzi e che, evidentemente, non vuole correre troppi rischi.
Ma se siamo ancora alle prese con commenti ed editoriali che scavano nei gangli, evidentemente incastrati e arrugginiti, del Partito liberale e non ci si focalizza, ad esempio, sulle evidenze economiche, come quella decisamente positiva di un budget che ad aprile tornerà a essere in attivo, e sulla visione politica, sulla direzione che questo governo vuole percorrere, non è certo responsabilità di noi osservatori che pure cerchiamo, almeno dalle colonne di questo bisettimanale, di offrire ai nostri lettori un quadro quanto più esaustivo della situazione politica generale del Paese.
Quello che abbiamo registrato, infatti, da agosto a oggi, non è stata un’offerta politica progettuale, non è stata una narrazione di una visione dell’Australia del futuro, ma è stato un continuo di recriminazioni personali, di fazioni in lotta tra di loro, di “mano invisibili” (vedi articolo a pagina 14), tra cui la più criticata sembrerebbe essere quella di Malcolm Turnbull che tra l’altro non ha fatto nulla per non far passare l’immagine di sé come di un ex politico astioso e vendicativo per motivazioni, legittime o meno, ma pur sempre di matrice personale e non politica.
E quindi ci chiediamo, e non siamo i soli a farlo, quale sia la tenuta attuale della leadership di un primo ministro che appare sempre più vulnerabile, soprattutto in ragione di continui tumulti interni. Tanto debole da non riuscire a rappresentare, agli occhi degli elettori, i risultati del lavoro del governo di Coalizione Abbott-Turnbull-Morrison. Elettorato, infatti, che nonostante i tentativi di minimizzare l’accaduto riportandolo a qualcosa che afferisce a contesti strettamente statali, ha punito duramente i liberali alle urne per il rinnovo del parlamento del Victoria.
Sconfitta che ha causato un vero e proprio terremoto all’interno del Partito liberale del Victoria con l’uscita, pochi giorni dopo la disfatta elettorale, del leader Matthew Guy e, ultima in ordine di tempo, quella del presidente del partito, Michael Kroger, che ha lasciato venerdì dopo una riunione dell’assemblea statale del partito.
Kroger, che era stato invitato a rassegnare le dimissioni in diretta televisiva dall’ex premier liberale del Victoria Jeff Kennett nelle ore immediatamente successive alla chiusura dei seggi, quando le dimensioni della disfatta ancora non erano così importanti, ha inviato a tutti i membri del suo partito un comunicato nel quale si è detto inizialmente convinto di dover rimanere alla guida fino alle elezioni federali del 2019 ma, ha poi ammesso: “Dopo aver letto diversi articoli di quotidiani, ho pensato che quando i tuoi stessi sostenitori ti stanno dicendo che sia giunta l’ora di farti da parte, probabilmente è proprio il caso di farlo. [Questo] perlomeno - ha aggiunto - permetterà a un presidente incaricato ad interim di avere sei mesi per continuare con i preparativi per arrivare alle prossime elezioni federali”.
Peraltro, restando in tema di elezioni statli del Victoria, è ancora incerto il risultato del seggio di Hawthorn, la cui riconferma, da parte dell’aspirante leader liberale John Pesutto è attualmente in bilico. Con il 90.7% di voti conteggiati infatti, al momento in cui chiudiamo questa edizione, Pesutto risulta in svantaggio di 164 voti rispetto allo sfidante, il laburista John Ormond Kennedy. Un’eventuale perdita del seggio da parte del ministro ombra alla Giustizia farebbe ovviamente perdere a Pesutto ogni possibilità di poter conquistare la leadership liberale.
Insomma un partito che, sia a livello statale che a livello federale, dovrà pensare a una profonda ristrutturazione sia in termini di dirigenza che di proposte politiche, per arrivare al voto di maggio con più solidità di quanta ne abbia oggi.