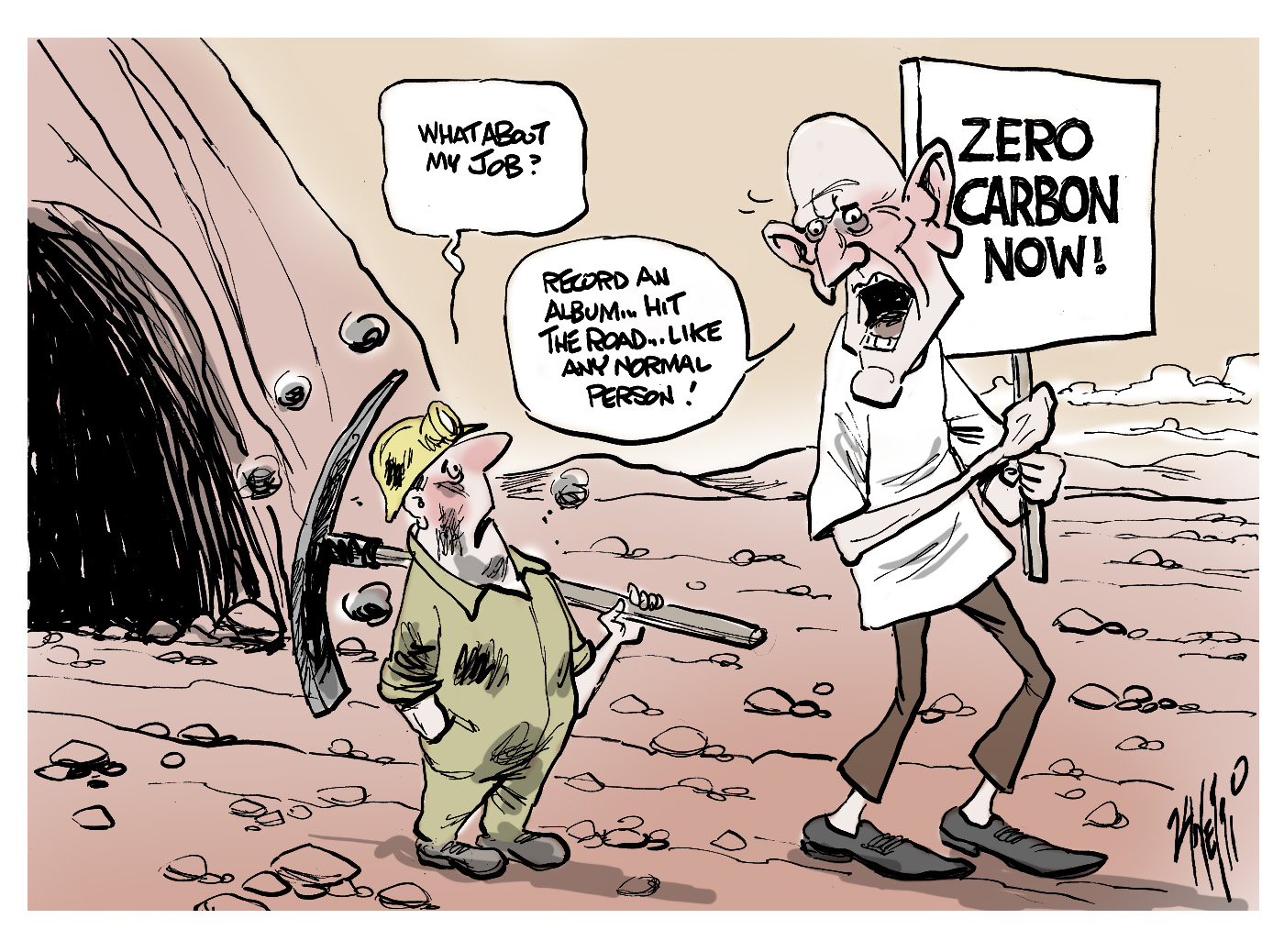Si chiudono i primi due decenni del nuovo millennio e l’Australia, così come molti Paesi avanzati, entra nel 2020 con tanti punti interrogativi. Tra i più rilevanti quelli ovviamente legati alla tenuta dell’economia, questione interconnessa con le vicende, altrettanto complesse, dei precari equilibri tra le grandi potenze mondiali.
La storia politica australiana di questo inizio di ventunesimo secolo la possiamo descrivere, usando una inevitabilmente poco esaustiva sintesi, in due grandi blocchi: un primo decennio di prosperità e solidità economica, con il consolidato record di ventisette anni di crescita consecutiva della cui flessione tuttavia, in questo ultimo anno, si è molto parlato, e un secondo decennio caratterizzato dalla estrema litigiosità ai vertici dei due storici blocchi politici di maggioranza.
In tutto questo, il panorama che, con l’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca e con la sempre più evidente ambizione di Xi Jinping, è cambiato così tanto da rendere gli equilibri nazionali e internazionali estremamente più fluidi.
Se nel corso del primo decennio di questo nuovo millennio la tradizionale struttura politica parlamentare ha tenuto tutto sommato bene agli scossoni che arrivavano da oltre oceano, evitando al Paese danni ben più gravi in conseguenza della grande crisi finanziaria del 2008, è anche vero che proprio in quegli anni siamo stati testimoni di quella che sarebbe diventata, almeno fino al mese di agosto del 2018, un’incandescente, e a volte poco edificante, abitudine: l’alternanza alla carica di primo ministro, in seguito alle lotte intestine prima all’interno del partito laburista e poi tra i liberali.
Un meccanismo che, come ricorda l’autore e giornalista politico George Megalogenis, nei primi 110 anni di politica federale australiana era stato utilizzato solo due volte ma che, dopo il 2010, ha lasciato sul ‘campo’ quattro vittime eccellenti, due per parte, Kevin Rudd e Julia Gillard sul fronte laburista e Tony Abbott e Malcolm Turnbull in casa dei liberali.
La vittoria alle urne di Scott Morrison, l’outsider che ha distrutto i sogni di gloria di Bill Shorten che si vedeva già con le chiavi della Lodge in mano, sembrerebbe aver messo fine, almeno a giudicare dalla dichiarata compattezza dei liberali, a questo stillicidio di viziosa alternanza ai vertici del partito e, di conseguenza, alla guida del Paese.
Non proprio un bell’esempio, pur se avvenuta nell’ambito di una dinamica di democratica dialettica interna alle strutture di partito, quest’alternanza a cui gli australiani hanno dovuto assistere negli scorsi anni è stata così poco apprezzata da essere restata tanto ben impressa nel ‘curriculum vitae’ di Bill Shorten e da aver rappresentato uno degli elementi di fascinazione negativa del candidato leader che, come è emerso nel recente rapporto laburista sulla sconfitta delle ultime elezioni federali, hanno contribuito, insieme con altri fattori, alla sua sconfitta.
Ma, al netto della personale vicenda politica dei protagonisti di queste battaglie interne, il vero dubbio, soprattutto a giudicare dalla confusionaria collocazione dell’Australia all’interno dello scacchiere internazionale, è se questi giochi di potere che hanno impegnato l’esecutivo australiano in questo decennio che sta per terminare abbiano o meno contribuito a distrarre i vertici politici del nostro Paese dall’analisi di un mondo che stava, e sta, cambiando. Le relazioni ‘pericolose’ tra gli Stati Uniti e la Cina stanno sostituendo quelle storiche, altrettanto poco equilibrate, tra Washington e Mosca, oggi decisamente più vicine nella comune comprensione che la nuova potenza economica di cui aver paura è proprio quella di Pechino.
Non è mai tardi per posizionarsi in maniera decisa e determinata all’interno di queste delicate relazioni internazionali, il tema è centrale per il governo Morrison e, questo appare chiaro, l’impegno non è certamente dei più semplici, visti i protagonisti in campo: da un lato la continua necessità di riconsolidare il primato e l’autonomia dell’economia statunitense da parte del tycoon e dall’altro la mai celata e sempre più strutturata ambizione del leader cinese Xi Jinping.
Il quadro all’interno del quale trovare uno spazio è decisamente complesso, anche perché stiamo parlando di equilibri di natura economica e commerciale intimamente connessi con quelli politici: numeri alla mano il Financial Times ha fotografato una realtà completamente mutata proprio nell’ambito di questi vent’anni. Se, infatti, all’inizio del 2000 gli Stati Uniti avevano un primato quasi globale in termini di esportazione, dal suo ingresso nell’Organizzazione mondiale del commercio (WTO) - fra qualche giorno ricorrerà il diciannovesimo anniversario - la Cina è diventata immediatamente l’esportatore più potente al mondo, inizialmente rosicchiando fette di mercato in tutto l’Oriente, in Africa e in Europa per poi, dal 2010 in avanti, rendere la situazione per Washington sempre più critica, conquistando, di fatto, il primato in tutto il mondo fatta eccezione per la parte nord del continente americano.
La questione dei rapporti di forza tra Stati Uniti e Cina ovviamente non è sintetizzabile esclusivamente dal punto di vista della potenza in termini di esportazione né, per quanto importante, della mera bilancia commerciale, ma va inquadrata in un ben più complesso scenario di visione strategica che, finora, almeno per quanto riguarda la lettura del fenomeno cinese, si sta rivelando ben poco efficace. Pechino infatti si è rafforzata con l’ingresso nel WTO ma senza, evidentemente, mutare il proprio sistema valoriale, restando pur sempre una potenza autoritaria che cerca, con complesse attività di intelligence, di avere sempre maggiore presenza e influenza su potenziali alleati. La sfida per il nuovo decennio che inizia, per Scott Morrison e i suoi uomini, è epocale: restare in equilibrio, il meno precario possibile, tra le due super potenze, senza perdere, si spera, autonomia, autorevolezza e solidità economica, sulla quale tra l’altro i dubbi sono già decisamente molti.