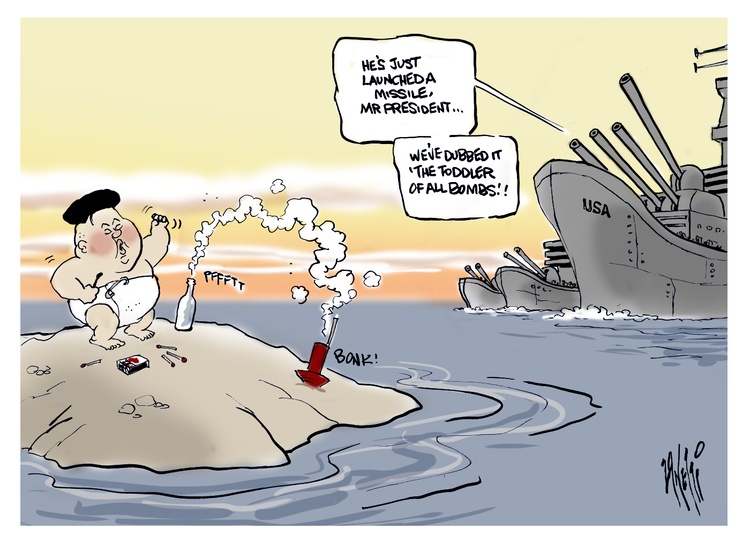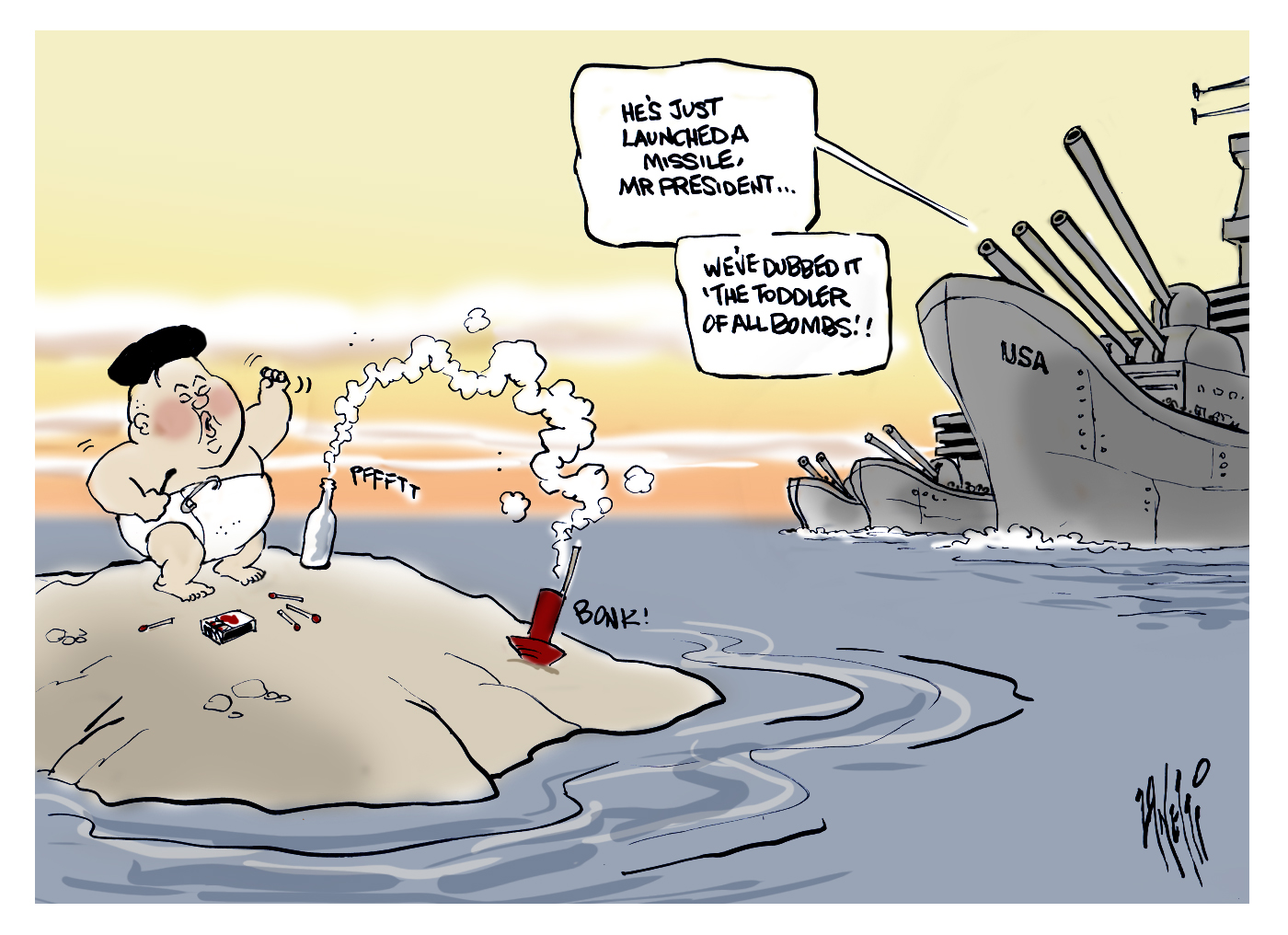Prima chiude e meglio è. Lo sa il governo di Papua Nuova Guinea (PNG), lo sa il governo australiano. La complicata fase degli accertamenti sui rifugiati detenuti nel campo profughi di Manus Island che dovrebbero essere accolti negli Usa in seguito allo ‘strano’ accordo stipulato tra Obama e Turnbull è iniziata, così come la trattativa con Paesi terzi (Cambogia in prima linea, ma anche Nauru) per il possibile invio di coloro che non verranno accettati dagli Stati Uniti.
Manus deve chiudere prima della fine dell’anno secondo l’intesa raggiunta da Port Moresby con Canberra, ma il ministro dell’Immigrazione Peter Dutton, assicura che a prescindere da quanti rifugiati si prenderà l’America, i ‘respinti’ non metteranno sicuramente piede in Australia. Ancora una volta però nessuna indicazione su dove saranno dirottati, continuando ad escludere le offerte umanitarie della Nuova Zelanda e del Canada. Non indietreggia di un passo Dutton imitato da Malcolm Turnbull nonostante le crescenti pressioni per un ripensamento, specie in virtù degli incidenti di un paio di giorni fa, con l’intervento della polizia di PNG per sedare una rissa tra rifugiati, militari e giovani di Manus al termine di una partita di calcio al di fuori del filo spinato. Un soldato ubriaco avrebbe dato il via ai disordini nel corso dei quali sarebbero stati sparati in aria colpi d’arma da fuoco nel tentativo di riportare l’ordine, anche se, secondo quanto è trapelato, alcuni proiettili avrebbero colpito le grate di alcuni locali nelle aree Mike e Foxtrot della struttura di detenzione. Nei tafferugli sarebbero stati lievemente feriti, a causa di lanci di pietre, anche alcuni addetti alla sicurezza che hanno cercato di controllare gli scontri e proteggere il rientro dei rifugiati nel complesso-prigione.
“La verità è - ha dichiarato Daniel Webb dello ‘Human Rights Law Centre’ - che a Manus è impossibile garantire la sicurezza sia dei detenuti che delle guardie”.
“La situazione è esplosiva dentro e fuori il centro - ha detto Webb - e quello che è accaduto venerdì scorso è l’ennesima prova che Turnbull deve far evacuare immediatamente il campo profughi in questione e portare i detenuti al sicuro in Australia”.
“La maggior parte di questi uomini – ha continuato l’esperto legale – sono stati riconosciuti come rifugiati anni fa. Gli attacchi dell’altra sera li ha terrorizzati e dopo quattro anni di limbo, paura e violenza, sono completamente esausti”.
Il direttore della Task Force delle Chiese australiane, Peter Catt, ha dichiarato che i negoziati con gli Stati Uniti possono continuare anche con i detenuti trasferiti al sicuro in Australia. Stesse accuse e stessi inviti da parte di Amnesty International mentre il portavoce dell’opposizione all’Immigrazione, Shayne Neumann, è stato molto più ‘diplomatico’ (i laburisti che hanno ‘inventato’ il progetto ‘mai in Australia’ sanno di non avere la coscienza perfettamente a posto per fare i critici e hanno soprattutto un’incredibile paura di farsi vedere meno decisi e severi dei liberali) parlando semplicemente della necessità di aprire un’indagine sull’accaduto.
Perfetta sintonia quindi tra governo e opposizione su un tema che elettoralmente continua a pesare, specie in certe aree del Paese: Shorten non intende fare l’errore di Rudd che, cancellando la famosa “Soluzione Pacifico” architettata da John Howard, aveva dato il via ad arrivi continui di imbarcazioni di disperati con decine di naufragi e centinaia di perdite di vite umane. Solo a ridosso delle urne, nel 2013, la marcia indietro e il tentativo di mostrarsi ancora più risoluto degli avversari per guadagnare qualche voto extra: da lì è nata la promessa del “mai in Australia” che la Coalizione ha accettato e confermato, facendola diventare una bandiera anti-arrivi via mare che nessuno ora si sente di ammainare.
Gli australiani, in linea di massima, ci stanno: le proteste ci sono ovviamente, ma non tanto convinte e ‘rumorose”, anche grazie alla strategia adottata dal governo delle comunicazioni centellinate al riguardo e della quasi impossibilità per i giornalisti di ottenere permessi per visitare le strutture extraterritoriali e raccontare liberamente quello che succede dietro il filo spinato a Manus e Nauru. Segretezza nel nome, sfruttato e spesso abusato, di una presunta “sicurezza nazionale” che gli australiani accettano con eccezionale tranquillità e scarsa umanità. Sicurezza nata dalla famosa ‘Operazione confini sicuri’, lanciata da Tony Abbott e affidata a Scott Morrison, quando l’attuale responsabile del Tesoro ‘volava alto’ ed era un po’ considerato il possibile successore dell’allora primo ministro.
A fianco del generale in congedo Jim Molan, Morrison aveva messo in mostra notevoli doti di fermezza e capacità di comunicazione ‘controllata’ che avevano permesso al governo di rispettare al meglio il famoso slogan elettorale del “fermare l’arrivo delle imbarcazioni di disperati”. Lo ‘stop the boat’ era stato servito talmente bene che a Morrison era stato chiesto il bis, in fatto di successi, spostandolo al welfare, una ‘promozione’ che non era stata particolarmente gradita, ma che era stata letta come un’ulteriore prova di apprezzamento e fiducia nei suoi confronti. Nel nuovo ruolo Morrison aveva offerto all’allora ministro del Tesoro Joe Hockey un piano di riforme riguardanti i servizi per l’infanzia da inserire nel budget, disegnato per rilanciare le fortune di un’amministrazione in grandi difficoltà dal punto di vista della popolarità, tanto che si erano già messe in moto le forze ‘antagoniste’ interne che avrebbero poi portato, anche grazie allo stesso Morrison indicato un po’ da tutti come l’uomo giusto per rimpiazzare un Hockey sempre più frustrato ed evanescente dal punto di vista politico, alla scelta salva-voti di Turnbull.
Accoppiata vincente? Accoppiata sicuramente poco convincente che, nel dopo mini-golpe, invece di partire con un piano preciso d’azione hanno cominciato, e nemmeno tanto in sintonia, a tirare sassi nello stagno delle cose da fare nascondendo la mano. Hanno aspettato le reazioni e hanno puntualmente fatto clamorose retromarce lasciando praticamente le cose esattamente com’erano per ciò che concerne regime fiscale, programmi per il rientro del deficit, incentivi per investimenti e lavoro. Ne è seguita una campagna anticipata per una conferma del mandato con Morrison che è apparso, anche grazie alle indecisioni di Turnbull, l’uomo non più tanto giusto per il ruolo che gli è stato affidato e la sua stella ha cominciato a brillare molto meno rispetto ai tempi dell’immigrazione, della comunicazione ferma e precisa con un piano altrettanto fermo e preciso sul da farsi. E così fra ormai solo tre settimane, Morrison si ritrova a dover sostenere l’esame che potrebbe segnare il suo futuro e quello del governo: il budget che dovrebbe fermare la spirale negativa in cui sembra essere precipitato il governo Turnbull. Ma da quello che trapela e, soprattutto, dalle aspettative che sono state create, non è il caso di farsi troppe illusioni. E’ stata data infatti enorme enfasi proprio ad uno dei problemi più difficili da affrontare, ma soprattutto sul quale il governo (qualsiasi governo) ha limitati poteri d’intervento: il caro-casa. Escludendo, come è stato erroneamente fatto, le pochissime vere carte a diposizione di Canberra (incentivi fiscali per gli acquirenti, ovvero ‘negative gearing’ e tassazione sugli utili di capitale) non resta molto da inventarsi per controllare un mercato esagerato dai favorevolissimi tassi d’interesse del momento e dall’attrazione ‘estera’ (prevalentemente cinese) per l’immobiliare australiano. Ma tutti ormai si aspettano da Morrison chissà quale fantastica soluzione che non arriverà. E, come nell’immediato dopo insediamento nel ruolo più importante dopo quello del leader, siamo ritornati ai sassi nello stagno delle idee: fondi di Superannuation da usare come deposito per l’acquisto della prima casa che sembrano diventati un po’ come l’idea del possibile rincaro della GST. Un’opzione che ha creato un acceso dibattito, soprattutto all’interno del Partito liberale, procurando nuove divisioni e malesseri. L’esame non promette bene e il Morrison che ha “fermato le barche” non sembra in grado di fermare il molto più importante, in un’ottica liberale, declino del governo.