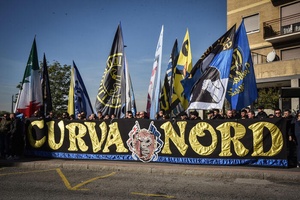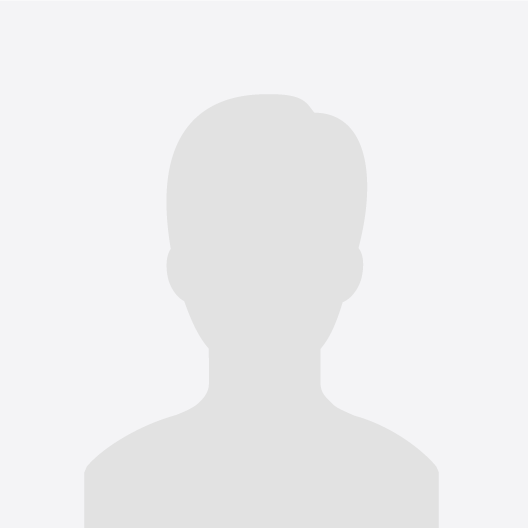Per gli studenti australiani che si affacciano al mondo universitario si aggiunge un nuovo elemento di valutazione nel considerare l’eterna contrapposizione tra studi umanistici e scientifici, con la riforma del ministro dell’educazione Dan Tehan passata al Senato grazie al voto del partito minoritario Centre Alliance.
In base al disegno di legge, alcuni corsi, soprattutto quelli dell’area umanistica, subiranno un incremento fino a oltre il 100% dei costi, mentre altri saranno meno onerosi.
Secondo il ministro Tehan la riforma era necessaria per incoraggiare i giovani australiani a scegliere un percorso di studi che offra maggiori sbocchi lavorativi e per spingerli verso le cosiddette materie STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).
“Nel mio ruolo di Associate Dean Research ho avuto tantissime discussioni con il personale universitario per capire come gestire questi cambiamenti – premette Andrea Rizzi, professore associato di Italianistica alla University of Melbourne -. Fondamentalmente il governo ha avuto alcune idee positive, ad esempio quella di offrire più posti universitari e di incrementare il numero di studenti in zone remote. I problemi cominciano a sorgere quando si riduce il finanziamento del governo alle università”.
“Poi c’è un attacco agli studi umanistici, che vengono visti in maniera errata come discipline che non portano al lavoro, cosa che è stata ampiamente confutata da una serie di ricerche. La più recente si chiama ‘The Graduate Outcome Survey’, del programma di sondaggi QILT (Quality Indicators for Learning and Teaching), uscita nel 2020. Lo studio ha dimostrato in maniera chiara e lampante che le prospettive lavorative per gli studenti delle scienze umanistiche sono identiche a quelle di coloro che studiano le discipline STEM. Inoltre è emerso che gli studenti di discipline umanistiche, sebbene a volte facciano più fatica a trovare un lavoro subito, nell’arco di 4 o 5 anni finiscono per guadagnare più degli studenti di discipline scientifiche”.
Laureato in Lettere Moderne a Pavia, Andrea Rizzi sapeva già al terzo anno di liceo di non avere altri interessi che non fossero la storia e la letteratura:
“Ci tenevo ad avere una preparazione umanistica per varie ragioni che il nostro caro Dan Tehan non prende molto in considerazione, e cioè la capacità di raccontare, spiegare e interpretare la storia e la cultura, e di apprezzare le diversità culturali. Un pacchetto di abilità che poi si sono rivelate molto utili perché prima di insegnare all’università ho lavorato nell’industria del turismo, organizzando tour culturali per scuole e università americane e viaggiando molto”.
Tra le numerose perplessità generate dal disegno di legge c’è anche la preoccupazione che possa creare ulteriori discriminazioni sociali.
“Nella nostra università il 71% degli iscritti a Lettere (Arts) sono studentesse, quindi con queste misure ci sarà un’ulteriore penalizzazione: costringerà molte donne ad avere un debito più alto di quello già esistente”, sottolinea Rizzi.
Anche la storia personale di Francesco Ricatti, ricercatore di Italianistica alla Monash University, è esemplare nell’illustrare l’importanza di seguire le proprie passioni al di là delle ideologie che contrappongono scienza e sapere umanistico.

Francesco Ricatti, ricercatore di Italianistica alla Monash University
“Mio padre era giudice, quindi una facoltà che non fosse Giurisprudenza era fuori discussione. Ho cominiciato a dare i primi esami a Legge e ho preso anche dei voti altissimi, per l’estrema contentezza di mio padre. Poi un giorno in cui stavo studiando la distanza tra i balconi per un esame di Diritto Privato, mi sono chiesto: ‘ma che m’importa della distanza tra i balconi?’”
“Mi ricordo benissimo di questo momento in cui ho deciso di passare a Lettere. Fu un periodo difficile, ma mio padre si rassegnò. E adesso mi chiedo come mi sarei comportato se mi fossi trovato in quel contesto di stress familiare, in cui tutti fanno pressione, con in più la prospettiva di dover pagare il doppio per studiare materie che tanti considerano inutili. E questo avrà quindi un impatto sulle persone più svantaggiate da un punto di vista socio-economico”.