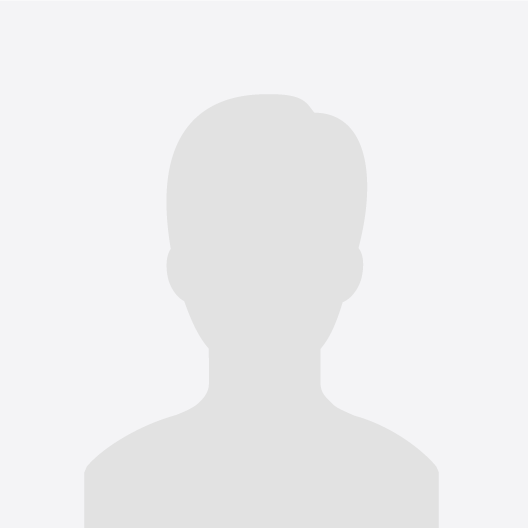BOLOGNA – Non è solo un romanzo per ragazzi “dedicato alla Nutella”. La fabbrica della Supercrema di Luigi Bellerini (San Paolo) è tanti romanzi in uno. Una storia d’amore tra due giovani, Lino e Teresa. La storia di un Paese da ricostruire da cima a fondo, dopo le ferite della Seconda guerra mondiale. E la storia di una famiglia di imprenditori che seppero creare una delle icone pop del 20° secolo.
“A me interessava soprattutto mostrare ai lettori più giovani che può esistere un mondo del lavoro sano, dove si riesce ad avere successo senza ricorrere allo sfruttamento”, dice Luigi Ballerini, che Il Globo ha incontrato a Bologna, alla Bcbf, la Fiera internazionale del libro per ragazzi che si svolge dal 31 marzo al 3 aprile.
“Sono affascinato dalla figura di Michele Ferrero”, ammette Ballerini. Figlio di Pietro, che con il fratello Giovanni, nel 1946, aveva trasformato una piccola pasticceria familiare in una fabbrica, dove iniziarono a produrre la “Supercrema”, che poi si sarebbe chiamata Nutella e sarebbe diventata famosa in tutto il mondo.
Per ricostruire la storia, Ballerini ha spulciato gli archivi della Ferrero e ha parlato con anziani ultranoventenni, i primi operai della fabbrica.
“I Ferrero sviluppavano i prodotti per rispondere a necessità già esistenti, anziché creare bisogni nuovi – dice lo scrittore –. Nel dopoguerra il cacao era carissimo, la cioccolata era un prodotto per pochi. Ma i lavoratori dovevano consumare gli alimenti energetici. Così pensarono di aggiungere le nocciole, di cui il Piemonte disponeva in abbondanza, per abbassare il costo senza perdere in sapore e sostanza”.
Inizialmente la Nutella era una specie di mattonella da tagliare a fette e mettere tra due fette di pane, come se fosse stato un salume, da portare al lavoro come pranzo al sacco”.
Anche i Pocket coffee, cioccolatini ripieni di caffè, nascono dall’osservazione di una necessità: mettere il caffè a disposizione dei camionisti, affinché non si addormentassero, in un’epoca in cui non esistevano gli autogrill sulle autostrade.
“Era un modo di fare impresa che oggi non esiste più, o quasi – continua Ballerini –. Basato sulle trattative, i negoziati, la costruzione di alleanze. C’era bisogno di forza lavoro, gli uomini non bastavano. Per convincere le famiglie a lasciare lavorare le figlie femmine, Michele si alleò con i parroci, che fecero da garanti della moralità dell’ambiente della Ferrero”. Con tutto quello che ha significato, per le donne, avere un proprio stipendio e l’indipendenza economica.
Ferrero, con altri imprenditori illuminati come Adriano Olivetti, crearono il welfare aziendale, prima che provvedesse lo Stato. “Ancora oggi, l’azienda assicura che, in caso di morte del proprio dipendente, finanzierà gli studi dei figli fino al compimento dei 26 anni”, racconta lo scrittore.
Il racconto prosegue con altri ricordi testimoniali. “Preparavano in fabbrica la cioccolata calda per i lavoratori del turno di notte – aggiunge –. Concedevano ai dipendenti i permessi per assentarsi nell’epoca della raccolta delle nocciole e dell’uva”. Per non sradicare le persone dalla loro storia, consentire di mantenere un’attività familiare che offriva un introito in più e al tempo stesso tutelare il territorio e le sue produzioni tipiche”.
Michele aveva anche una profonda fede cattolica, di cui non si vergognava. Anzi. Il Ferrero Rocher nasce dalla sua devozione alla Madonna: la carta dorata è il manto della Vergine, le nocciole che spuntano sono le pietre della grotta di Lourdes.
Oggi, la Ferrero ha sedi in altri Paesi del mondo, a cominciare dall’Argentina, dove il Gruppo è arrivato 1993, distribuendo – oltre alla Nutella – Ferrero Rocher, Kinder, e Tic Tac. Lo stabilimento della Ferrero in Argentina si trova a Los Cardales, in una zona industriale (a forte presenza di aziende italiane) nella provincia di Buenos Aires. È una delle tante grandi aziende italiane (come Pirelli e Techinit) con una sede “dall’altra parte del charco” (la pozzanghera, come i migranti chiamavano scherzosamente l’oceano Atlantico).
La crema, tuttavia, viene prodotta nella fabbrica del Brasile, nello Stato di Minas Gerais, dallo stabilimento argentino escono i Rocher. In America Latina il gruppo è presente anche in Cile, anche in Messico, Ecuador e Colombia.
Ma il processo di internazionalizzazione era già iniziato nel 1956, con l’apertura di uno stabilimento in Germania. “Internazionalizzazione – sottolinea lo scrittore –. Non delocalizzazione, che invece è un modo per produrre all’estero, con costi minori”. E lasciare sul lastrico le famiglie italiane”.