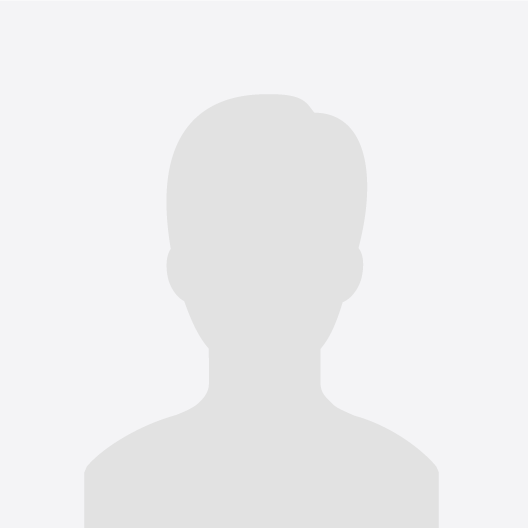C’è una grandissima differenza tra un ‘raid’ dei Servizi segreti australiani e quello della polizia cinese nelle abitazioni di giornalisti dei due Paesi. Non ci sono dubbi da che parte qualcuno preferirebbe stare.
Ciò non toglie che l’azione dei servizi australiani dello scorso giugno (altro servizio a pag. 13) ha sicuramente contribuito alla reazione, da condannare senza riserve, delle autorità cinesi, tanto da forzare un immediato ritorno in Australia, e non senza qualche più che giustificata apprensione, dei corrispondenti dell’Abc, Bill Birtles e del Financial Review, Mike Smith, che lavoravano rispettivamente a Pechino e Shanghai.
Rientro in sicurezza in Australia, con l’aiuto delle autorità diplomatiche, dopo quattro giorni di comprensible timore di un drammatico evolversi negativo della situazione.
Lieto fine, ma triste realtà di una fase sempre più tesa fra i due Paesi che hanno disperato bisogno uno dell’altro e, soprattutto, un chiaro messaggio ai cittadini australiani che, per ragioni di lavoro, sono in questo momento in Cina: potrebbero trovarsi nel bel mezzo di un estremamente spiacevole braccio di ferro, ben poco diplomatico.
Era dal 1989, dal massacro di Piazza Tienanmen, che le relazioni tra Canberra e Pechino non erano così precarie e, purtroppo, trent’anni dopo, il necessario rientro dalla crisi sembra essere molto più complicato di quello che è stato in quell’occasione. Ormai è un sommarsi costante di episodi che mettono in evidenza una crescente animosità e la chiara determinazione di Pechino di mantenere sotto pressione l’Australia. Prima l’azione ‘punitiva’, via dazi, nei confronti degli esportatori australiani di orzo e carne (ai quali in un secondo momento sono andati ad aggiungersi quelli del vino), poi l’invito piuttosto chiaro a studenti e potenziali turisti di dimenticare l’Australia quando si potrà ricominciare a viaggiare.
Al momento sembrano rimanere al riparo di rimostranze e penalizzazioni, per evidente convenienza dei destinatari, le esportazioni minerarie, con ferro, gas e carbone che, sommate, incidono per oltre 109 dei 169 miliardi di dollari di export australiano verso la Cina.
Nessuno deve però illudersi che continuerà ad essere sempre così: sembra infatti che, nell’ambito della nuova strategia globale del regime di Xi Jinping, Pechino stia sviluppando nuove miniere di ferro in Africa e costruendo una vera e propria flotta di maxi-navi per ridurre i costi di trasporto di minerali dal Brasile (concorrente dell’Australia per qualità e prezzo del prodotto, ma penalizzato per ora dalla distanza). Quindi non solo Washington e Canberra stanno seriamente prendendo in considerazione come ovviare alla ‘dipendenza’ di alcune importazioni dalla Cina (come prodotti sanitari), ma anche la Cina sta, forse ancora più seriamente, valutando come ovviare alle sue esigenze d’importazione da ogni altro Paese del mondo che non si piega alla nuova linea intransigente di un regime, decisamente cambiato, con cui il dialogo è diventato molto più duro e difficile.
Dietro le quinte comunque, nonostante le indubbie tensioni e gli scambi da ‘vetrina politica’ per il pubblico di casa, si lavora alacremente per cercare di smussare le difficoltà del momento e riportare le relazioni fra Canberra e Pechino più vicine possibile ad una normalità (che non ha mai significato completa serenità e sincera fiducia reciproca) che gioverebbe ad entrambi i Paesi. Ma non sarà facile ritornare indietro senza fare qualche tipo di concessione, specie al riguardo del bando dell’azienda cinese Huawei nello sviluppo della rete 5G che, di fatto, ha dato il via alla reazione a catena di provvedimenti anti-Australia.
L’unica consolazione, che rafforza la risposta, una volta tanto, abbastanza solida di Canberra, è il fatto che l’Australia non è sicuramente la sola a subire quella che sembra sempre più essere una arrogante reazione di Pechino ad un nuovo corso politico internazionale nei confronti delle sue evidenti mire espansionistiche. Negli ultimi dodici mesi la Cina ha in qualche modo ‘punito’ con dazi, espulsioni, minacce anche Stati Uniti, India, Unione Europea, Gran Bretagna, Canada, Repubblica Ceca, Svezia, Vietnam, Filippine, Nuova Zelanda, Corea del Sud e Giappone (con gli ultimi due gli attriti erano cominciati ancora prima).
Perché la verità è che, a partire dal 2012, qualcosa è cambiato a Pechino. L’arrivo sulla scena di Xi Jinping ha ribaltato le antiche strategie dell’attesa, dell’aspettare il momento favorevole che aveva caratterizzato qualsiasi azione dei precedenti leader, e si è passati invece ad una dichiarazione pubblica di forza, un’azione costante di espansione in tutto l’Occidente. Non a caso è arrivata l’ambiziosa “One Belt One Road Initiative”, che ha ammaliato anche il premier del Victoria Daniel Andrews con quelle allettanti offerte di scambi e sviluppo commerciale e infrastrutturale.
Ma attraverso gli anni, seguendo nei dettagli le iniziative e i Paesi che vi hanno aderito, è diventato sempre più chiaro il rovescio della medaglia dell’operazione: cosa c’è veramente dietro la generosità rivolta specialmente alle nazioni in via di sviluppo, la strategia cioè che mira a creare una vasta e importante rete politico-commerciale che lega Asia, Africa ed Europa.
Fanno parte del piano di Pechino, infatti, le nuove linee ferroviarie in Vietnam, Laos, Cambogia e Malesia, oltre a quella ad alta velocità tra Londra e Yiwu, e lo sviluppo dei porti nelle Filippine, Bangladesh, Sri Lanka, India, Oman, Iraq, Somalia e Grecia.
Il progetto della ‘nuova Via della Seta’, oltre che in Australia (anche se il governo federale ha promesso un intervento correttivo in merito alla scelta dell’amministrazione Andrews), lo scorso anno è arrivata anche in Italia, sollevando non poche rimostranze sia a Washington che a Bruxelles.
Rapporti quindi che rimangono incerti a tutti i livelli, ma non è sicuramente più incerta a nessun livello la tattica espansionista di Pechino, che potrebbe prendere degli ancora più seri connotati internazionali nei prossimi mesi, con un possibile intensificarsi delle pressioni su Taiwan, fortemente legate all’esito delle presidenziali Usa dopo il recente mutamento della politica degli Stati Uniti nei confronti dell’isola in questione. Una nuova linea improntata ad un sostegno sempre più diretto ed esplicito in risposta alla strategia di ‘accerchiamento’ militare e diplomatico da parte di Pechino.
L’Australia è direttamente coinvolta in tutto questo, specie dopo le ferme prese di posizione di Morrison sull’atteggiamento cinese per ciò che riguarda l’espansione, via prestiti agevolati e aiuti ‘materiali’ per nuove infrastrutture, che hanno sottratto al Paese (e agli Usa) le ‘amicizie’ ufficiali di Kiribati e delle Isole Salomone.
In gioco, quindi, un intreccio di interessi che vanno al di là di quelli strettamente economici. Diplomazia al lavoro pertanto su tutti i fronti: da quello dell’allineamento militare con Washington, per ciò che riguarda le politiche regionali di contenimento della Cina nell’area dell’Indo-Pacifico, a quelle commerciali. Del mantenere cioè gli scambi che servono a Pechino per sostenere un’economia che, dopo l’esplosione del COVID-19, sta notevolmente rallentando e all’Australia per uscire dalla profonda recessione causata dalla pandemia. Alleati in affari per mutua necessità, costretti a cercare compromessi senza dare l’impressione di non mantenere la barra dritta sui loro diversi principi ed ideologie.
I rapporti tra Canberra e Pechino sono sempre stati complicati e hanno vissuto diversi saliscendi di umori e attività. Questa volta però la strada per ritornare a toni meno accesi e minacce con meno possibilità di concretizzarsi, dà l’impressione di essere particolarmente lunga e piena di insidie: il Covid, le richieste di chiarezza lanciate proprio dall’Australia in merito, lo ‘schiaffo’ (imitato poi da altri Paesi occidentali) del ‘no’ alla Huawei, l’irrigidimento sugli investimenti e i più che giustificati sospetti su interferenze politiche, non aiutano di certo ad accorciarla o semplificarla.