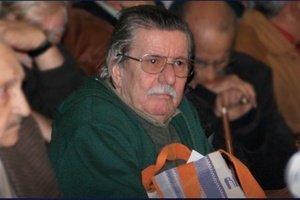Lo sa già, ma qualcuno comunque glielo ricorderà, anche se in questo momento le priorità sono altre.
La prossima settimana Anthony Albanese sorpasserà tutti i suoi predecessori alla Lodge nel dopo Howard, diventando il primo ministro più longevo al timone del Paese dopo l’uscita di scena dell’ex capo di governo liberale.
Salirà al 12esimo posto in assoluto e, a conclusione di questo suo secondo mandato, arriverà all’ottavo posto (su 31 primi ministri della storia politica australiana), con la quasi certezza, per come si sono messe le cose a Canberra, di avere davanti almeno altri tre anni di governo, quindi con tutto il tempo a disposizione per scalare ulteriormente la classifica e lasciare il segno anche per quanto riguarda riforme o traguardi raggiunti durante la sua guida della nazione.
Ci aveva provato subito a passare alla storia con il referendum sulla Voce indigena, ma gli è andata male e per la repubblica non c’è molta speranza: non sembra ci sia una gran voglia di andare a toccare l’assetto costituzionale, con l’esempio che stanno dando presidenti vari intorno al mondo. Purtroppo, sempre per la storia, Albanese sarà sicuramente ricordato per essere stato alla guida del governo in occasione del più grave attentato terroristico che ha colpito l’Australia, ma potrebbe comunque costruire qualcosa di positivo se riuscirà a guidare una svolta, forte e duratura, contro l’antisemitismo che grava come un macigno sulla nazione.
Ci saranno ovviamente tante altre possibilità per ottenere altri tipi di riconoscimenti per avere cambiato in qualche modo il Paese, come è stato per Bob Hawke con la storica decisione del cambio flessibile del dollaro e l’introduzione del Medicare; per Paul Keating con l’obbligatorietà del sistema di versamenti sui fondi pensione (Superannuation) e il trattato di Mabo sulle proprietà terriere della popolazione indigena; per Howard con l’introduzione della tassa sul valore aggiunto (GST) e la legge, senza precedenti, sulle armi da fuoco in seguito al massacro di Port Arthur.
Albanese ha tutto il tempo per lasciare il segno a lungo termine anche perché potrà, se lo riterrà opportuno, premere un po’ di più il pedale dell’acceleratore sulle riforme e lasciare poi che alcuni cambiamenti apportati in numerosi campi, comincino ad avere un chiaro effetto pratico per poter essere considerati di importanza significativa per il miglioramento della qualità di vita degli australiani: sicuramente ambizioso il piano di arrivare ad un sistema universale dei servizi per l’infanzia; già degna di nota la novità mondiale del divieto di accesso ai social network ai minori di 16 anni (l’esempio australiano è ora seguito da molti paesi); tutto invece ancora da vedere per ciò che riguarda l’ossessione-energetica di Chris Bowen, con quel traguardo del 62-70 per cento di riduzione delle emissioni, entro il 2035, rispetto ai valori del 2005; la concretizzazione del piano AUKUS; un posto per l’Australia al tavolo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Albanese e il suo governo possono farcela, anche perché hanno il campo piuttosto libero grazie ad una Coalizione impegnata soprattutto a cercare soluzioni per la sua sopravvivenza, per cercare cioè di ritrovare una sufficiente stabilità interna in modo di poter ricominciare a parlare con una parte della società australiana con la quale sembra non avere più alcun tipo di comunicazione. Dopo la larga vittoria elettorale di Tony Abbott, nel 2013, c’è stata infatti una netta frattura con alcuni settori, che si sono allontanati sempre più dal mondo sempre più ristretto e confuso di quella che era sempre stata una credibile alternativa di governo. Dialogo completamente interrotto con il mondo in continua espansione dei valori ‘progressisti’ nelle classi professionali della nazione, con una crescente ostilità nei confronti della Coalizione nel mondo accademico, tra i laureati, nella comunità artistica, nei media pubblici – ABC e SBS -, nel pubblico impiego, nel settore non profit, nelle lobby per i cambiamenti climatici, nel campo delle energie rinnovabili, tra molti leader delle comunità etniche, le donne e gli elettori più giovani.
E a complicare il tutto, l’attacco sul terreno di ‘casa’ delle ‘indipendenti Teal’, sponsorizzate da Climate200, che fanno da cuscinetto tra i liberali moderati e laburisti e verdi, mentre sale l’inquietudine a ‘destra’, dei conservatori più conservatori che si sentono minacciati dalle politiche in bianco e nero di One Nation.
Coalizione quindi stretta in una morsa che la sta consumando internamente, tra chi la vorrebbe più moderna e al passo con i tempi su alcuni temi sociali e chi invece - sull’esempio di quanto è successo in America con Trump ma anche in altre nazioni europee – spinge per una maggiore presa di distanze dal progressivismo ‘woke’ delle ingiustizie sociali, razziali, di genere, delle discriminazioni e dei torti di un passato che non si può riscrivere, puntando sugli indubbi problemi della transizione energetica con i suoi costi e le sue incertezze, i programmi d’immigrazione, e quelle che ritengono preoccupanti debolezze nel campo della sicurezza nazionale e della coesione sociale. Più che mai Ley contro Taylor ed entrambi contro Hanson che ha dalla sua, oltre al caos d’identità liberal-nazionale, la coerenza: basta sostituire le paure che la leader di One Nation sventolava alla nascita del partito, nel 1997, sull’invasione cinese con l’attuale presunta ‘invasione musulmana’ e per il resto la senatrice del Queensland ha sempre mantenuto la barra dritta. Sulla sua lista programmatica: più patriottismo, meno immigrazione, no al multiculturalismo, troppi sussidi per la popolazione indigena che deve assumersi le sue responsabilità senza aiuti a pioggia. Aggiustamenti invece, guardandosi indietro sul fronte energetico con il rilancio del carbone per far scendere i costi energetici e le riserve di gas assicurate, con almeno il 15% dell’intera produzione riservato al mercato nazionale. Come per Kyoto, al passo con i tempi, ora c’è il no all’accordo sul clima di Parigi.
Il più recente sondaggio Newspoll catapulta la squadra Hanson al 27 percento di consensi virtuali, togliendo il fiato e i voti non certo ai laburisti, ma alla Coalizione precipitata al 18 percento di seguito diretto (15 per i liberali, 3 per i nazionali). E la storia politica insegna che quando il voto di One Nation sale, è quello dei conservatori a scendere (nel ’98 l’ascesa del partito di protesta rischiò di far perdere a Howard le elezioni della prima riconferma, riducendo la sua maggioranza da 44 a 12 seggi). Pertanto Taylor, Hastie, Littleproud, Canavan e insoddisfatti vari, farebbero bene a prendere nota: per riprendere quota meglio differenziarsi dalle semplificazioni Hanson-Joyce e non prendere esempio da un populismo, in stile Trump - con slogan, pericoli e nemici da combattere (identificando nell’immigrazione la causa di problemi economici e sociali), protezionismo -, che non aiuta di certo a riprendersi un minimo di attenzione al di fuori della cerchia degli arrabbiati, dei delusi, di coloro che non si sentono adeguatamente rappresentati e vogliono in qualche modo protestare e punire i partiti tradizionali. Dopo i sondaggi, un primo test già il prossimo mese (21 marzo) quando il South Australia andrà alle urne per la conferma scontata del governo laburista di Peter Malinauskas: secondo l’ultimo rilevamento Fox-Hedgehog sulle intenzioni di voto i laburisti mantengono un netto vantaggio con il 40% dei consensi, One Nation è al 20%, i liberali al 19%, con previsioni di una massiccia perdita di seggi che farebbe scendere la loro presenza in Parlamento dagli attuali 13 a solo cinque rappresentanti. Una disfatta nella disfatta.