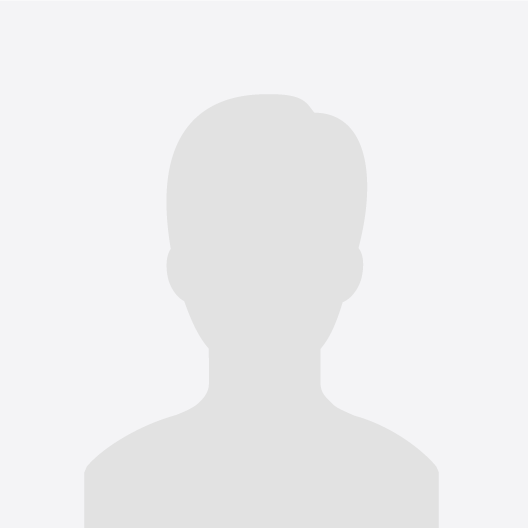Fra le tante buone intenzioni del governo Albanese c’è anche quella di ritrovare una certa normalità nei rapporti con la Cina: il Primo ministro l’ha detto fin dall’inizio del suo mandato e qualche tentativo di dialogo c’è già stato.
La strada è lunga e difficile, ma da percorrere, tenendo conto del mutuo interesse perché principi, valori e ideali sono una gran bella cosa, da seguire e rispettare, ma poi ci sono anche le realtà della vita di ogni giorno, le strategie geopolitiche, le semplici convenienze pratiche, l’economia che non fa sconti. La Cina continua a fare i suoi interessi a tutto campo non andando troppo per il sottile: l’ha dimostrato da sempre, solo accentuando negli ultimi anni i toni minacciosi e le ambizioni.
Non appena Canberra si è distratta (governi Abbott e Morrison), la Cina si è presa – grazie alla superficialità dell’amministrazione del Northern Territory - il controllo, per 99 anni, del porto di Darwin e ha creato tutti i presupposti, pur negando categoricamente la possibilità e le intenzioni, per piazzare una base navale, a poco più di 2000 chilometri dalla costa orientale dell’Australia, nelle isole Salomone.
Nello stesso tempo non ha mai dimenticato il torto che ritiene di avere subito in relazione alla decisione dell’allora primo ministro Malcolm Turnbull di vietare all’Huawei (gigante cinese delle telecomunicazioni che, non solo secondo l’intelligence australiana, lavorerebbe per conto dell’esercito di Pechino) di partecipare alla gara d’appalto per la costruzione delle infrastrutture e della rete 5G, imponendo una serie di ‘punizioni’ commerciali su importazioni di beni e servizi australiani. Il regime di Xi Jinping rimane però opportunisticamente interessato a comprare tutti i minerali che gli servono per continuare il suo piano di espansione economica, senza i freni che il mondo ha imposto ai paesi industrializzati, rivendicando il suo diritto di recuperare terreno, rimanendo tra le nazioni in via di sviluppo per almeno altri dieci anni.
Incurante di giudizi e critiche sulla sua amicizia con Mosca nonostante la crisi ucraina, continuando sulla strada di un espansionismo non solo economico, dal 21 settembre la Cina è diventata il più grande acquirente di idrocarburi russi. Putin ringrazia e incassa dal regime ‘dell’amico Xi’ circa 330 milioni di dollari australiani al giorno mentre ne perde ‘solo’ 226 dall’Europa e le sue sanzioni.
Pechino, nonostante il suo impegno a medio e lungo termine sul fronte climatico, continua ad ampliare il suo ‘arsenale’ di produzione energetica fossile avendo sul territorio operative ben 258 centrali a carbone (secondo i dati riportati lo scorso luglio dall’agenzia internazionale Global Energy Monitor), con quasi altrettante in via di progettazione o già in fase di costruzione.
E così mentre il mondo sta cercando disperatamente di tagliare le emissioni di Co2 (l’Australia ha riscoperto la voglia, che era già stata manifestata da Kevin Rudd nel 2007, di guidare o quasi le ambizioni planetarie, con quel traguardo del 43 per cento di riduzione dei veleni entro il 2030 fatto diventare addirittura ‘legge’), la Cina dal 2015 al 2021 ha aumentato la produzione di gas serra dell’11 per cento. E la tendenza al rialzo continuerà, secondo i piani di Pechino, fino al 2035, poi inizierà la discesa con il traguardo della neutralità carbonica da raggiungere nel 2060, dieci anni dopo il resto del mondo industrializzato.
Niente marce indietro per ora su nessun fronte: Taiwan rimane sempre nel mirino, con la minaccia che continua ad aleggiare di possibile intervento militare; la Russia resta un sicuro partner non solo commerciale mentre l’Australia deve continuare a fare i conti con dazi e restrizioni.
Nonostante le buone intenzioni e le dichiarazioni di una chiara volontà di riavvicinamento espresse sia dal ministro degli Esteri australiano Penny Wong che dalla sua controparte cinese Wang Yi ad un recente incontro a New York, nulla è effettivamente cambiato nelle relazioni commerciali tra i due Paesi: i dazi appesantiti su alcuni prodotti restano, le riduzioni di ordini in altri settori anche, ma restano anche in questo rapporto sempre teso e sempre proficuo le maxi esportazioni, oltre che di materiali ferrosi, di gas mentre il carbone, pur rimanendo tra i prodotti ‘penalizzati’ riprende gradualmente quota tanto da far registrare, nel 2021, vendite per 260 milioni di tonnellate, dopo lo stop alle importazioni imposto da Pechino nel 2020.
Nessuna restrizione invece per il gas liquido, con l’Australia al primo posto fra i Paesi esportatori verso la Cina nel 2020-21 (30,7 milioni di tonnellate circa). Un po’ meno nel 2021-22, ma comunque l’export di LNG ha generato entrate per circa 90 miliardi di dollari.
Se anche le esportazioni di carbone riprenderanno a crescere, per il governo Albanese ci sarà un ulteriore ‘bonus’, dopo quello ‘ereditato’ per il 2021-22, che ha regalato a Jim Chalmers circa 48 miliardi extra sul fronte del deficit di partenza per il suo budget del 25 ottobre.
Il ministro del Tesoro aveva parlato di circostanze favorevoli e prezzi delle materie prime particolarmente alti che non sarebbero rimasti a lungo a quei livelli. Martedì però, in concomitanza con l’ennesimo intervento della Banca centrale sui tassi d’interesse (sesto aumento di fila), sono arrivate nuove previsioni favorevoli sul fronte dell’export: crescita e prezzi sostenuti per almeno altri dodici mesi per ciò che riguarda il settore energetico e i profitti minerari, con altri 40 miliardi di ‘bonus’ per i conti di bilancio anche per il 2022-23, rispetto ai numeri presentati da Josh Frydenberg lo scorso marzo.
Ecco allora, la possibilità, secondo l’economista di Capital Economics, Marcel Thieliant, che quel passivo di gestione per il prossimo anno, preventivato a 78 miliardi, potrebbe essere ben diverso se Chalmers manterrà le promesse riguardo al contenimento delle spese.
Il dipartimento d’Industria, delle Scienze e delle Risorse ha preventivato prezzi ancora al di sopra della media delle materie prime per almeno altri dodici mesi, in conseguenza ai problemi energetici globali e al diminuito valore del dollaro australiano rispetto alla controparte americana. Cambio favorevole, domanda sostenuta, prezzi ancora su, anche se destinati a scendere nel 2023-24, quando è anticipato un ritorno alla normalità in fatto di offerta e produzione pre-Covid. Una ‘normalità del settore delle Risorse e dell’Energia che dovrebbe comunque fare entrare nelle casse federali circa 375 miliardi di dollari (il terzo valore annuale più alto di sempre).
Ci siamo andati vicini nel 2019 a quel ritorno in attivo che Morrison e Frydenberg avevano disperatamente inseguito a dimostrazione della mitica presunta ‘superiorità gestionale’ della Coalizione. Poi è arrivata la pandemia e il governo conservatore è diventato improvvisamente laburista in fatto di interventi miliardari a pioggia per fronteggiare un’emergenza senza precedenti. Deficit e debito abissali inevitabili e almeno tre o quattro mandati per poter ritornare a parlare di bilanci in attivo.
Chalmers frena giustamente qualsiasi entusiasmo, ma i numeri nelle stanze del Tesoro cominciano a sembrare molto meno drammatici e un secondo ‘bonus’ il prossimo anno potrebbe fare seriamente pensare ad una corsa incredibilmente accorciata, con tutte le conseguenze politiche del caso, verso il Sacro Graal di qualsiasi amministrazione federale.