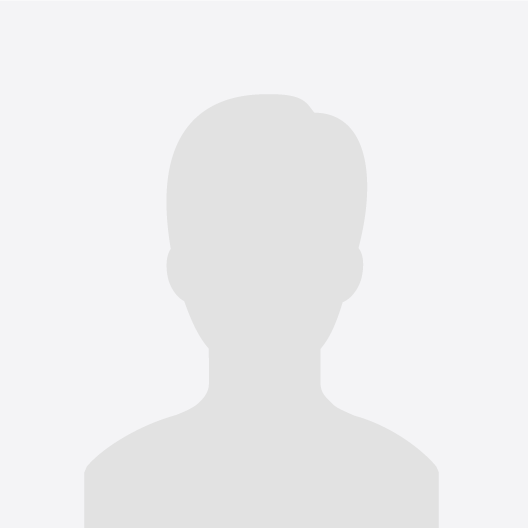Il Pozzo di San Patrizio a Orvieto non è solo un capolavoro dell’ingegneria rinascimentale, ma potrebbe essere anche un’opera figlia della bellezza dei numeri, in particolare della sezione aurea e della sequenza di Fibonacci. È questa l’ipotesi di Luciano Cencioni, medico e grande appassionato di storia, che ha studiato le proporzioni del Pozzo e ne ha individuato sorprendenti corrispondenze con la costante di Fidia, il celebre 1,618. “Nel mondo esistono opere eterne, caratterizzate da una struttura matematica che ne determina l’armonia e la bellezza oggettiva - spiega Cencioni -. Ne sono esempi la Piramide di Giza, il Partenone, la Cappella Sistina, la Gioconda e persino l’uomo Vitruviano. Tutte queste opere condividono un rapporto numerico preciso, che il nostro cervello riconosce istintivamente come bello”. “La bellezza dei numeri s’identifica nella sezione aurea, una proporzione matematica conosciuta fin dall’antichità e riscoperta da Keplero nel 1611 attraverso lo studio della sequenza di Fibonacci”, ricorda Cencioni. Secondo il quale, appunto, anche il Pozzo di San Patrizio segue questa logica numerica. “Se prendiamo il diametro del cilindro interno, pari a 4,65 metri, e lo moltiplichiamo per la costante di Fidia (1,618), otteniamo circa 7,5 metri”, spiega ancora Cencioni. “Sommando questo valore al diametro interno, arriviamo a 12,17 metri, praticamente quello del cilindro esterno, che è di 12,20 metri - sottolinea - e questo dimostra che la proporzione aurea è presente nel progetto del Pozzo, anche se probabilmente in modo inconscio da parte del Sangallo”. Nel 1202 il matematico pisano Leonardo Fibonacci pubblicò il “Liber abbaci”, un trattato di aritmetica e algebra con il quale voleva introdurre in Europa il sistema numerico decimale indo-arabico e i principali metodi di calcolo a esso relativi. All’interno del trattato portò diversi problemi aritmetici con relativa soluzione. In matematica, la successione di Fibonacci (detta anche successione aurea) è una successione di numeri interi in cui ciascun numero è la somma dei due precedenti, eccetto i primi due che sono, per definizione, 0 e 1.