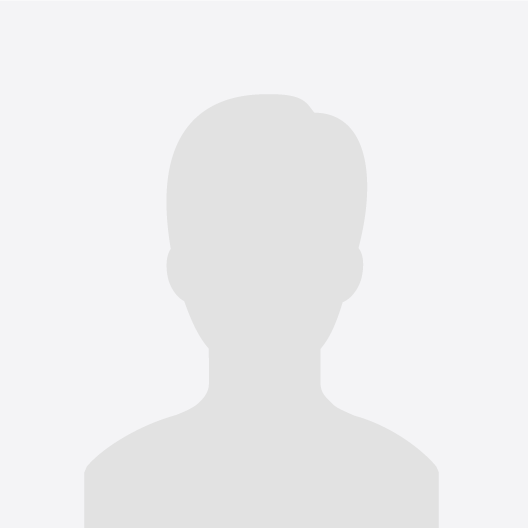Come in tutte le cose la fortuna non risolve tutto, ma aiuta. Perfino nei rapporti con la difficile Cina, che sono arrivati al livello di guardia e hanno urgente bisogno di una svolta positiva. Esattamente come è successo cinquant’anni fa, quando l’allora leader dell’opposizione Gough Whitlam,18 mesi prima di diventare primo ministro, si è ritrovato a Pechino allo stesso tempo di Henry Kissinger, a quel tempo Consigliere per la Sicurezza Nazionale Usa, che stava organizzando quella che poi sarebbe diventata la storica visita del presidente Richard Nixon. La missione di Whitlam era puramente diplomatica, un tentativo di rilanciare le relazioni con la Cina del premier Zhou Enlai.
Guarda caso, al centro dei colloqui Taiwan e l’assicurazione diplomatica di Whitlam del riconoscimento di ‘una sola Cina’, quindi di non sostenere le rivendicazioni di indipendenza dell’isola, pur assicurando di mantenere separati e forti i rapporti economici e culturali con la stessa Taiwan.
Niente sfoggio di muscoli, ma una posizione chiara senza forzature che Pechino ha accettato favorevolmente, e una presa di distanze da qualsiasi altra decisione che avrebbero poi preso gli Stati Uniti al riguardo. Una dimostrazione di maturità ed indipendenza decisionale, senza compromettere le relazioni con Washington dato che, nel febbraio del 1972, l’amministrazione americana è arrivata alle stesse conclusioni, con la firma da parte di Nixon e del suo omologo cinese Zhou dello ‘Shanghai Communique’, che con calcolata ambiguità riconosceva sia l’esistenza di una unica Cina sia l’appartenenza di Taiwan alla ‘entità unica cinese’.
Ma Whitlam l’aveva fatto per primo e Pechino aveva apprezzato, aprendo la strada per più di 40 anni di relazioni positive, seppur non senza intoppi e crisi come quella in occasione della strage di Piazza Tiananmen. Questo fino a quando la Cina è profondamente cambiata, diventando sicuramente più aggressiva e ambiziosa sotto la guida di Xi Jinping, ma la situazione è rapidamente precipitata anche perché l’Australia qualche passo falso l’ha fatto: la richiesta, seppur legittima, in diretta tv, da parte del ministro degli Esteri, Marise Payne, di un’inchiesta indipendente sulle origini della pandemia di coronavirus non è stata il massimo della diplomazia.
Certo poi non aiuta quando un leader, per celebrare i 100 anni del Partito Comunista Cinese, compare sul palco rispolverando la divisa maoista e dice: “Noi cinesi siamo un popolo che difende la giustizia e non si lascia intimidire dalle minacce della forza. Come nazione, abbiamo un forte senso di orgoglio e fiducia. Non abbiamo mai maltrattato, oppresso o soggiogato la gente di nessun altro paese, e mai lo faremo. Allo stesso modo, non permetteremo mai a nessuna forza straniera di prevaricare, opprimerci o soggiogarci. Chiunque tenti di farlo si troverà in rotta di collisione con una grande muraglia d’acciaio forgiata da oltre 1,4 miliardi di cinesi”.
Un messaggio rivolto ai 95 milioni di membri del PCC, a 1,4 miliardi di cinesi e al mondo intero. All’Australia in particolare era già partito un avviso mirato e diretto lo scorso 7 maggio, quando Il Global Times di Pechino, una delle tante fonti non ufficiali del governo, aveva scritto che in caso di qualsiasi intervento armato statunitense, appoggiato da Canberra nel Mar Meridionale cinese, avrebbe fatto arrivare i suoi missili a lungo raggio su obiettivi militari in Australia.
Toni propagandistici che disturbano, ma che non dovrebbero essere ribattutti colpo su colpo: la politica del braccio di ferro continuo adottata dall’amministrazione Morrison, infatti, non aiuta nessuno. L’hanno fatto notare in questi giorni i governi del Queensland, del Western Australia e del New South Wales che hanno sottoposto, come richiesto, all’esame del Foreign Arrangment Scheme (FAS), contratti del valore di miliardi di dollari. Dopo la cancellazione del trattato di intenti firmato del Victoria nell’ambito dell’iniziativa ‘Belt and Road’, sono in gioco accordi commerciali, investimenti, gemellaggi tra università e comuni, alcuni in vigore da più di trent’anni. Sotto scrutinio anche gli uffici di rappresentanza in Cina aperti dal governo del Queensland per facilitare gli scambi commerciali, mentre il premier del WA, Mark McGowan, ha invitato i colleghi federali a non compromettere ulteriormente le relazioni fra i due Paesi, sottolinenando che il 56 per cento dell’export del suo Stato finisce in Cina. Nel New South Wales ci sono 2011 memorandum d’intesa con il Ministero delle Scienze e Tecnologia cinese finiti sotto il microscopio del FAS.
Occhio insomma a non esagerare con i controlli e i ripensamenti ‘storici’ perché, come ha detto il primo ambasciatore australiano in Cina, Stephen FitzGerald, l’Australia deve trovare il modo di riaprire i canali diplomatici con Pechino, sia quelli davanti agli occhi di tutti sia quelli, da sempre esistiti e altrettanto importanti, dietro le quinte. La politica è anche questo, ma Canberra in questo momento non sembra prenderlo in considerazione, lasciandosi guidare dalle rigide direttive formulate nell’ambito della sicurezza nazionale.
“È una Cina diversa, ma nemmeno quella del 1971 era particolarmente morbida e aperta”, ha ricordato FitzGerald. “Oggi è economicamente molto più potente – ha continuato -, ma bisogna comunque cercare il dialogo con chiunque, a prescindere di quello che si pensa di un altro Paese. Cosa che stanno già facendo Singapore, la Corea del Sud, il Giappone e il Vietnam”.
Morrison ha ricevuto esattamente lo stesso consiglio dalla sua controparte di Singapore, Lee Hsien Loong, nella tappa verso la Cornovaglia: dialogo e non scontro aperto; nessuno chiede che si rinunci ad essere se stessi, che si debba cambiare il modo di pensare, ma nessuno può nemmeno aspettarsi che la Cina possa improvvisamente diventare un Paese occidentale e democratico. Ci saranno sempre angoli da smussare, e qualche compromesso da accettare, ma il fine giustifica e richiede maggiore tolleranza e un pizzico di creatività e calcolata ambiguità, anche perché altre soluzioni non ci sono.