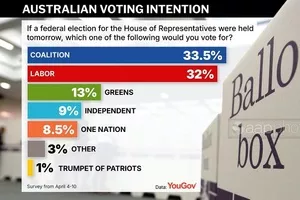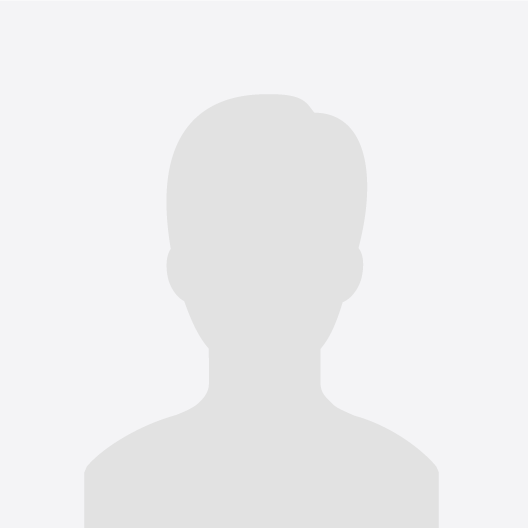BEIRUT – Il primo ministro libanese, Saad Hariri, ha rassegnato le dimissioni dopo aver tentato di frenare le proteste che da due settimane paralizzano il Paese. “Le mie dimissioni sono la risposta alle richieste delle piazze”, ha spiegato Hariri. Non è chiaro se il capo del governo, generale Michel Aoun, abbia accettato le dimissioni di Hariri.
Secondo quanto riportato dai media locali, a portare in strada un milione di persone, era stato l’annuncio di nuove tasse. Presto, agli slogan e agli striscioni, si sono però aggiunti gli scontri con la polizia, che hanno provocato due morti e almeno 60 feriti.
In pochi giorni, nonostante l’esecutivo abbia approvato varie riforme, le manifestazioni si sono trasformate in proteste antigovernative. “Non lasceremo le strade finché non se ne saranno andati tutti questi politici”, si leggeva in alcuni striscioni esposti durante le proteste.
A differenza di quanto accaduto nel 2011, quando i cittadini arabi erano insorti contro le varie autocrazie del Medio Oriente, la protesta libanese nasce da problemi economici e sociali.
Secondo recenti stime dell’Onu, l’1% della popolazione detiene circa il 25% del reddito nazionale, e nel 2017 il 20% dei depositi bancari era concentrato in circa 1600 conti correnti, pari allo 0,1% di tutti i depositi bancari. Il Libano ha anche uno dei debiti pubblici più alti al mondo, cresciuto del 2000% dal 1990, con un rapporto debito/Pil del 150% e interessi altissimi.
Ai problemi economici si aggiungono quelli infrastrutturali. La rete elettrica serve solo il 65% della popolazione, motivo per cui lo Stato non riesce a garantire la corrente elettrica 24 ore su 24. Anche l’approvvigionamento idrico è un problema, tanto che in alcune aree della Capitale l’acqua di rubinetto è salata.
Infine, c’è la corruzione, che colpisce soprattutto il mercato del lavoro. Chi cerca impiego deve conoscere qualcuno che lo metta in contatto con un politico, che a sua volta cercherà un’occupazione per il richiedente, ma lo farà solo in cambio di una promessa di “fedeltà” politica. Insomma, un voto di scambio, che rafforza l’establishment, oggi integralmente sotto accusa.