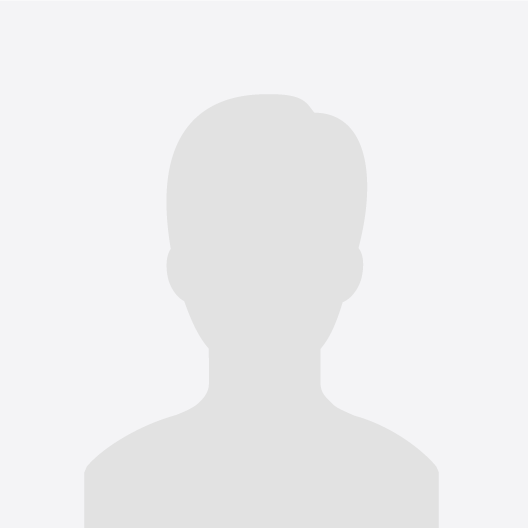Siamo ai primi giorni di campagna elettorale, la sfida è in pieno svolgimento, e anche se queste battute iniziali non hanno ancora offerto temi particolarmente entusiasmanti tali da spostare l’asticella del consenso dall’una o dall’altra, ci sono invece tematiche di grande interesse il cui impatto non è da sottovalutare.
A contribuire ad accendere i riflettori sul panorama internazionale in queste prime battute di campagna elettorale è stato l’ex primo ministro Malcolm Turnbull nel corso di un intervento, martedì, al National Press Club (NPC).
L’ex primo ministro liberale non si è risparmiato, dal ritorno del tycoon alla Casa Bianca, nel manifestare le proprie opinioni, per molti fronti decisamente negative, sulla nuova amministrazione Trump.
Altrettanto si può dire dal lato di Washington, con le recenti dichiarazioni di Trump che hanno definito proprio Turnbull un “leader debole e incapace”. Le tensioni tra i due risalgono ai tempi in cui Turnbull era alla Lodge: nel 2017, nel corso del primo mandato alla Casa Bianca, una telefonata sul tema dell’accordo siglato da Barack Obama per accogliere negli Stati Uniti i migranti di Manus Island e Nauru, ebbe toni molto accesi, tale da essere definita dallo stesso Trump come la conversazione “di gran lunga peggiore” tra quelle avute in quei giorni con i vari leader mondiali.
Ma, tornando all’attualità dell’intervento di Turnbull al National Press Club e del Sovereignty and Security Forum, organizzato dallo stesso Turnbul a Canberra il giorno prima, neanche troppo sotto traccia è emerso il personale risentimento nei confronti dell’accordo AUKUS. Turnbull non ha mai ben accolto l’abbandono, da parte di Scott Morrison, del progetto di costruzione di sottomarini che lui stesso aveva sottoscritto con i francesi di Naval.
L’ex primo ministro ha approfittato del forum, e dell’intervento al NCP per chiedere ad Anthony Albanese e Peter Dutton di “alzarsi in piedi” e difendere l’interesse nazionale, anziché continuare a “stare in ginocchio” davanti a Washington. Una posizione che, con tono e intento evidentemente provocatorio, solleva una questione reale, ovvero quanto sia solida oggi l’alleanza con gli Stati Uniti, soprattutto ora che sembra più chiaro che mai il ritorno sulla scena di un presidente statunitense incline al bilateralismo diplomatico e, soprattuto, all’unilateralismo quando si tratta di imporre dazi e tariffe commerciali.
Eppure, anche i messaggi giusti possono essere lanciati nei momenti e nei modi sbagliati. Intervenire con questo impatto all’inizio di una campagna elettorale, polarizzando il dibattito su Trump e AUKUS, rischia di trasformare un confronto strategico e politico in un regolamento di conti personali. In un momento in cui la leadership politica ha bisogno di stabilità e chiarezza, l’invettiva di Turnbull rischia di apparire più come una rivendicazione personale che come un contributo costruttivo.
C’è però un altro aspetto emerso dall’evento di lunedì a Canberra che merita attenzione: l’idea – sostenuta da alcuni partecipanti al forum e da pubblicazioni accademiche recenti – secondo cui l’Australia dovrebbe “collaborare” con la Cina su questioni marittime, come la sicurezza delle rotte, la criminalità transnazionale o il cambiamento climatico.
L’argomentazione, avanzata ad esempio dall’accademico Edward Chan, appare in teoria ragionevole. Ma nella pratica rischia di legittimare la narrazione cinese che, pur affermando di non avere alcuna volontà di interferire con la campagna elettorale in corso, nella pratica sembra andare in tutt’altra direzione.
Solo poche ore fa il Global Times, quotidiano ufficiale del Partito Comunista Cinese, ha espresso una posizione che è difficile definire di non interferenza: “Alcuni politici australiani non ci arrivano. Cercano di bloccare il miglioramento delle relazioni Cina-Australia, vomitando costantemente retorica dannosa e dirottando questa relazione, solo per il loro tornaconto personale - si legge in un editoriale -. La Cina non è una minaccia. Su questo punto, l’Australia può dormire sonni tranquilli. Non deve essere così paranoica”.
Se a questo aggiungiamo quanto accaduto dall’inizio di quest’anno, ovvero esercitazioni militari senza preavviso, violazioni delle leggi sul diritto del mare, costruzione di isole artificiali in acque altrui, pesca illegale su vasta scala, uso strumentale delle milizie marittime, non vediamo come sia possibile restare neutrali nell’obiettivo della difesa della sicurezza nazionale.
Dutton e Albanese proprio ieri hanno giocato a rilanciarsi reciproche responsabilità e accuse sulla presunta debolezza nei confronti della Cina ma è ovvio che, al di là del batti e ribatti dal tono puramente elettorali, resta l’interrogativo principale rispetto alla necessità di dialogo e di cooperazione internazionale, in chiave strategica ma, come detto, con la primaria attenzione sulla della difesa e promozione degli interessi nazionali.
Cina, Stati Uniti, AUKUS, dazi, continua e naturale adesione al blocco delle democrazie occidentali, fatta la somma di tutti questi fattori, la vera domanda da porre in questa campagna elettorale e se l’Australia sia pronta a diventare una potenza strategica autonoma in un mondo dove sembrano essere venute meno le certezze di un tempo.
Il dibattito tra autosufficienza e alleanza, tra Asia e America, tra deterrenza e diplomazia non si può più rimandare. Ma per affrontarlo serve un approccio olistico, con meno nostalgia di un passato che non esiste più, maggiore strategia e meno retorica. In gioco non c’è solo la politica estera, ma il posto dell’Australia nel mondo. E il racconto di questa visione, oltre alle soluzioni immediate dei problemi contingenti dell’oggi, dovrebbe essere al centro della campagna elettorale che ci porterà verso il voto 3 maggio.