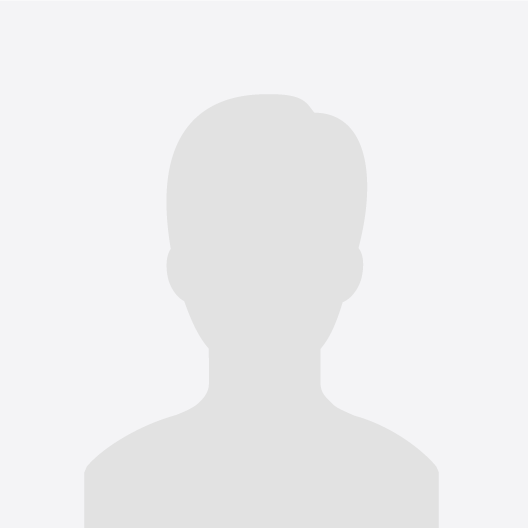Di solito, la politica commerciale non è in cima alle priorità del dibattito pubblico durante una campagna elettorale. È vista come una materia tecnica, da lasciare ai funzionari e agli ambasciatori e alle medie e grandi aziende in prima linea quando si tratta di imposizioni tariffarie.
Ma in questo aprile 2025, in Australia e non solo, si racconta tutta un’altra storia. Lo sapevamo già, il ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump avrebbe cambiato molto le carte in tavola a livello di relazioni internazionali, e non soltanto sul fronte prettamente della narrazione e di una ‘alternativa’ forma di intendere la diplomazia.
Nei giorni scorsi da Washington però si è parlato di sostanza, certo, anche qui non è mancata tanta retorica, ma il pacchetto di dazi presentato da Trump nel corso del Liberation Day rende il tema della politica commerciale una vera e propria bomba a orologeria che costringe tutto il mondo, Australia compresa, da Canberra ai più remoti distretti agricoli del Queensland, a ripensare le certezze su cui si fondavano le relazioni commerciali e strategiche del nostro Paese con il resto del mondo.
Ci siamo ormai, le giornate di campagna elettorale scorrono rapidamente, si avvicina la data del 3 maggio con un voto che, come sempre, sarà inevitabilmente una scelta di visione del Paese, della sua posizione nello scacchiere globale, della direzione da prendere tra apertura e protezionismo, tra multilateralismo e dialogo bilaterale. La mossa di Trump incombe ora più che mai, rimescolando le carte di una campagna elettorale già incerta e polarizzata.
Non siamo gli unici, anzi, e tutto il mondo sta trattenendo il fiato. La Cina, bersaglio privilegiato degli Stati Uniti, si è vista colpire con tariffe che superano ormai il 50%. L’Unione europea, il Giappone, l’India, tutti penalizzati con aumenti tra il 20% e il 34%.
Colpisce il fatto che, pur con termini meno ‘aggressivi’, anche l’Australia sia stata inclusa in questa ‘guerra’ commerciale, nonostante la lunga alleanza strategica tra i due Paesi, partendo dall’AUKUS fino al trattato di libero scambio ancora formalmente in vigore e nonostante il fatto che l’Australia sia uno dei pochi Stati con un surplus commerciale verso Washington.
Per molti questa scelta è risuonata come un campanello d’allarme. Non possiamo più sentirci l’eccezione, il partner privilegiato, l’amico che può permettersi di restare fuori dalle dispute globali. Siamo parte, a pieno titolo, delle tensioni del nuovo ordine mondiale. E la politica australiana non può più permettersi di ignorarlo. Il primo ministro Anthony Albanese ha reagito con una calma che alcuni, soprattutto dall’opposizione impegnata a provare a non garantirgli un secondo mandato, hanno definito troppo diplomatica, troppo passiva.
Nessuna rappresaglia, nessuna escalation verbale. Albanese ha definito i dazi “un gesto ingiusto” e “non da vero amico”, ma ha preferito non alzare i toni. Il suo ragionamento è strategico: evitare una frattura aperta con l’amministrazione Trump, proteggere gli interessi immediati del Paese senza però “partecipare a una corsa al ribasso” e guadagnare tempo per rinegoziare, eventualmente, dietro le quinte.
Ma l’opposizione, guidata da Peter Dutton, ha fiutato l’occasione. L’attacco è partito subito. Secondo Dutton e la sua squadra, infatti, il governo avrebbe dovuto muoversi in anticipo, costruire un rapporto diretto con la nuova amministrazione americana, usare l’influenza diplomatica maturata nel quadro dell’AUKUS e dell’alleanza del QUAD per garantire l’esclusione dell’Australia dalle misure punitive.
Per Dutton, la debolezza del primo ministro dimostra una mancanza di preparazione e di volontà politica. “Albanese non è riuscito a difendere il nostro interesse nazionale,” ha dichiarato in un comizio a Townsville. “Se non parliamo con forza ora, saremo ignorati domani”.
La questione, però, va ben oltre la dialettica da campagna elettorale. I dazi americani sono solo la punta dell’iceberg. Sotto la superficie, c’è un cambiamento sistemico che sta ridefinendo le regole del commercio globale. Trump non lo nasconde: il suo obiettivo è fare ripartire l’economia americana, rivitalizzare la produzione interna, costringere le aziende a scegliere tra accesso al mercato statunitense o delocalizzazione.
È una forma di neo-mercantilismo che parla alla classe operaia ormai disillusa che si è sentita abbandonata, alle combattive forze sindacali dell’industria pesante, di quella automobilistica, a chi rivendica principi di ‘patriottismo’ economico. E, in termini politici e di consenso, almeno a Washington, sembra avere funzionato.
Ma in queste occasioni, laddove si salvaguarda l’equilibrio interno di un Paese, il prezzo, come sempre, rischiano di pagarlo gli altri. L’Australia, con la sua economia fortemente dipendente dall’export e legata a doppio filo ai mercati asiatici, è tra quelle più vulnerabili.
I dazi, se mantenuti in queste condizioni, inevitabilmente andranno a indebolire la competitività dei nostri prodotti sul mercato americano. Le aziende più piccole, quelle che non possono assorbire i costi o diversificare in fretta, saranno le prime a soffrire. E se la Cina, tra i bersagli più duramente colpiti da Trump, dovesse reagire con nuove misure ritorsive o forme di destabilizzazione economiche, l’effetto domino potrebbe colpire duramente anche le esportazioni di materie prime australiane su cui, va ricordato, si basa gran parte del nostro surplus commerciale.
Questo quadro geopolitico non passa inosservato agli elettori. In molte aree rurali, dove l’agricoltura e l’allevamento dipendono dai mercati esteri, cresce la preoccupazione. Nei sobborghi urbani, la minaccia inflazionistica derivante da prezzi più alti per i beni importati, la volatilità dei mercati finanziari, gettano nuove ombre su una ripresa economica già fragile.
Le famiglie, che ancora sentono il peso dell’inflazione post-pandemia e dell’impatto del crescente costo della vita, sembrano purtroppo destinate a diventare le vittime collaterali di una guerra commerciale che non hanno scelto.
Per questo, l’effetto Trump in Australia è ormai anche un effetto elettorale. I laburisti alla ricerca di un secondo mandato cercano di smorzarne la portata, puntando sulla loro credibilità internazionale, sulla capacità di mantenere aperti i canali diplomatici e sulla dichiarata resilienza dell’economia australiana. Promettono investimenti in nuove aree di esportazione, un maggiore sostegno alle PMI e una rinnovata strategia indo-pacifica per controbilanciare le turbolenze. Ma devono fare i conti con l’accusa, sempre più insistente, di passività e scarsa incisività.
La Coalizione, invece, parla il linguaggio di chi invoca barriere difensive, incentivi per rilocalizzazione industriale, maggiore autonomia energetica e strategica. La loro è una proposta che guarda a un’Australia più chiusa, più autosufficiente, più assertiva, in generale. Una proposta che, in certi ambienti, trova un’eco sorprendente.
La pandemia ha lasciato cicatrici profonde nella fiducia collettiva nelle catene di fornitura globali. La guerra in Ucraina e le tensioni a Taiwan hanno reso palpabile il rischio di essere dipendenti da attori instabili. In questo contesto, il discorso protezionista non è più tabù. È una possibilità politica. Ma è anche una trappola.
Gli economisti, dentro e fuori dal Paese, avvertono che la strada dei dazi è lastricata di effetti indesiderati: aumento dei costi, rallentamento degli investimenti, riduzione dell’innovazione. La storia lo dimostra. E se oggi Trump promette di rilanciare l’industria americana, lo fa sacrificando l’efficienza globale per ottenere benefici locali immediati. Una scelta comprensibile che potrebbe trasformarsi in un boomerang.
L’Australia, in questo contesto, deve decidere chi vuole essere. Un Paese che difende l’ordine globale basato sulle regole, che investe nelle sue relazioni diplomatiche e commerciali, e che diversifica con intelligenza. Oppure una nazione che si chiude nel recinto dell’autarchia selettiva, tentando di proteggersi da un mondo sempre più instabile. Entrambe le opzioni hanno una logica. Ma richiedono scelte chiare.
Il voto del 3 maggio sarà, insomma, anche questo: una scelta sulla visione di Australia nel nuovo mondo dei blocchi commerciali, delle alleanze sempre più fluide, della politica economica a colpi di messaggio sensazionalisti. Trump, pur non essendo candidato, è già diventato protagonista della campagna. E quello che accade a Washington si riverbera, inevitabilmente, nelle urne australiane.