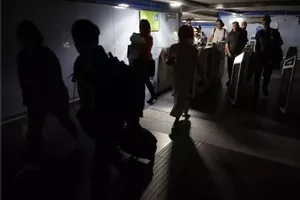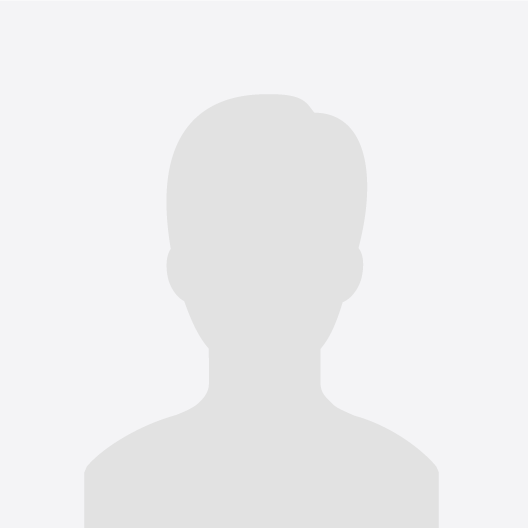La storia del Paese fortunato regge sempre e va al di là del Paese-miniera, delle risorse naturali di cui l’Australia abbonda e che continuano a sostenere la sua economia. Il Paese può ritenersi fortunato anche per come ha potuto difendersi dalla pandemia del coronavirus partendo con, i più volte sottolineati, vantaggi geografici, di scarsa densità di popolazione, di clima, di solidità politica, di tempi di preparazione rispetto al diffondersi dell’infezione, di qualità del sistema sanitario.
E fortunata l’Australia potrebbe continuare ad essere anche dal punto di vista del futuro perché la Cina, nonostante le difficoltà che sta creando in alcuni settori dell’export, continua ad importare massicci quantitativi di ferro e carbone.
Paese fortunato perché Pechino, continuando a rifornirsi massicciamente soprattutto di prodotti metallurgici australiani sta sostenendo la ripresa e offrendo un cruciale cuscinetto temporale al governo e alle aziende australiane per organizzare quella diversificazione dei mercati dell’export di cui si parla da anni, puntando, per esempio, con maggiore convinzione sulla crescita economica dell’India. Un Paese con cui è molto più facile dialogare e che ha, tra l’altro, in Australia una solida presenza anche a livello comunitario con cittadini che sono propensi a costruire ponti e non a distruggerli: 660mila - secondo i dati dell’ufficio centrale di statistica - i nati in India residenti in questo continente nel 2019, al terzo posto, come numero di nati all’estero, dopo britannici e cinesi.
L’India partner commerciale sempre più importante che sta rapidamente raggiungendo la Cina per ciò che riguarda le importazioni di carbone, che sta investendo nel settore con la controversa miniera Adani nel nord del Queensland - un’azienda che è anche la maggior produttrice di energia solare del Paese -, ma che offre soprattutto all’Australia nuove opportunità di investimenti e di mercato in altri svariati settori. Particolarmente interessante quello dell’istruzione, con l’annuncio-invito dello scorso anno del governo di Delhi di dare la possibilità di aprire campus universitari sul suo territorio. Considerando che l’India sta investendo enormemente sugli studi terziari, con uno straordinario 57,8 per cento della sua popolazione adulta che possiede una laurea (in Australia solo il 28,2 per cento), è per le maggiori università australiane un’opportunità da non lasciarsi sfuggire.
Il tempo è dalla parte dell’Australia che al momento, comunque, nonostante ritorsioni, minacce, dazi, navi bloccate, continua a fare registrare un bilancio estremamente positivo nell’interscambio con il gigante asiatico, a dimostrazione che la politica è una cosa e gli interessi economici un’altra. Nel mese di dicembre le esportazioni di minerale di ferro sono arrivate a 40 milioni di tonnellate (il 79 per cento dell’intera produzione australiana), un incremento del 25 per cento rispetto al mese precedente, dovuto ad una crescente espansione manifatturiera nel Paese del dragone.
Ma non solo ferro. Anche l’esportazione dei cereali verso la Cina è aumentata facendo registrare un incredibile balzo in avanti, nell’arco di 12 mesi, del 681 per cento, mentre il grano ha fatto entrare nelle casse australiane 250 milioni di dollari dopo il congelamento di agosto.
Un mini-boom dunque, che concede prezioso tempo per pianificare un futuro diverso, ma anche per cercare, come continua a sottolineare il primo ministro Scott Morrison, di ristabilire un minimo di ‘normalità’ nei rapporti tra i due Paesi, non escludendo un incontro diretto con il leader cinese Xi Jinping per far ripartire il dialogo interrotto con la richiesta, da parte australiana, di un’indagine indipendente sulle origini del Covid-19 (inchiesta da poco avviata, condotta dall’Organizzazione mondiale della sanità), ma anche dalle prese di posizione di Canberra nei confronti di Pechino sul fronte della sicurezza interna con la bocciatura (con tanto di massimo risentimento) dell’azienda cinese Huawei dalla gara d’appalto per le piattaforme tecnologiche 5G, oltre che le limitazioni e i maggiori controlli sugli investimenti internazionali (apertamente diretti alla Cina) in Australia. Richieste e provvedimenti legittimi che hanno portato ad un deterioramento dei rapporti diplomatici e commerciali che Morrison sarebbe ben lieto di poter ripristinare. Sarebbe un successo politico di grande portata che non farebbe altro che confermare l’appuntamento delle urne entro la fine dell’anno e il terzo mandato.
Ben venga l’incontro, ha detto il primo ministro in un’intervista lunedì scorso, ma senza paletti e condizioni: un dialogo franco e aperto con l’obiettivo di superare incomprensioni e diffidenze nell’interesse di entrambe le nazioni. Una richiesta decisa e precisa, senza compromessi dopo un anno di punitivo silenzio da parte del governo cinese che non ha più risposto ad alcun tentativo di contatto dei ministri australiani. Linee di comunicazione bloccate, ritorsioni commerciali e accuse lanciate da un nuovo gruppo di giovani funzionari che sembrano aver abbandonato di proposito le vecchie regole della prudenza e della pacatezza, portando avanti l’aggressiva narrazione stabilita da Pechino, specie dopo l’emergenza Covid. Una linea di difesa che è stata definita la diplomazia del ‘lupo guerriero’ che non sta interessando solo l’Australia.
Un nuovo approccio internazionale che era stato annunciato abbastanza apertamente dal ministro degli Esteri Wang Yi che, subito dopo l’inizio della pandemia, aveva suggerito ai suoi diplomatici di difendere in modo deciso e uniforme gli interessi della Cina e la sua reputazione internazionale. Operazione indubbiamente riuscita con il presidente Xi Jinping che, nel suo primo intervento pubblico dopo l’elezione di Joe Biden al Forum Economico Mondiale (appuntamento virtuale) ha ‘avvisato’ il mondo (ma in modo particolare gli Stati Uniti) di non usare la pandemia come pretesto per un ritorno ad una specie di guerra fredda. Xi Jinping, partendo dalla posizione di forza di un Paese uscito dal contagio e unica grande economia a registrare una crescita nell’anno più cupo dalla seconda guerra mondiale, ha invocato l’eliminazione di ogni barriera doganale (un invito che fa a pugni con tutto quella che la Cina sta facendo nei confronti dell’Australia) e ha parlato di “competizione equa”, basata sull’eccellenza invitando a separare la globalizzazione dalla politica che ha comunque usato per condannare “arroganza e pregiudizi, l’odio di chi cerca di stabilire una gerarchia nella civiltà umana”. “Ogni Paese è unico nella sua storia, cultura e sistema sociale e nessuno è superiore agli altri”, ha affermato il leader cinese, confermando quello che ormai sembra un nuovo approccio di Pechino sul palcoscenico globale, di nuova grande potenza e non solo economica. Gli aerei fatti sorvolare su Taiwan nei giorni scorsi è un altro chiaro messaggio a Biden e al mondo. “C’è solo una Cina e Taiwan è parte inalienabile del territorio cinese”, ha detto Wang Yi. Una risposta all’impegno di Washington, ribadito dal nuovo presidente Usa, per una “pacifica risoluzione” della questione secondo “i desideri e gli interessi del popolo” dell’isola.
Messaggi piuttosto chiari su entrambi i fronti, ma non proprio sulla stessa linea di pensiero in fatto di obiettivi. “Le decisioni non si devono prendere mettendo in mostra i muscoli o agitando il pugno (...). I forti non devono comportarsi come dei bulli verso i deboli e il multilateralismo non deve diventare il pretesto per l’unilateralismo di alcuni”, ha sottolineato Xi dando l’impressione di voler ribadire quello che considera il suo ruolo di leader non solo di una potenza in ascesa, che si sente discriminata e ostacolata nella sua crescita e influenza internazionale, ma di almeno altri 150 Paesi in via di sviluppo che l’uomo forte di Pechino, attraverso la strategia della Via della Seta, sta ‘aiutando’ tessendo una scaltra rete di alleanze che, in molti casi in seguito a debiti impossibile da ripagare, diventano sottomissioni.