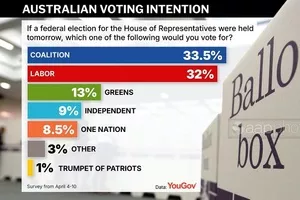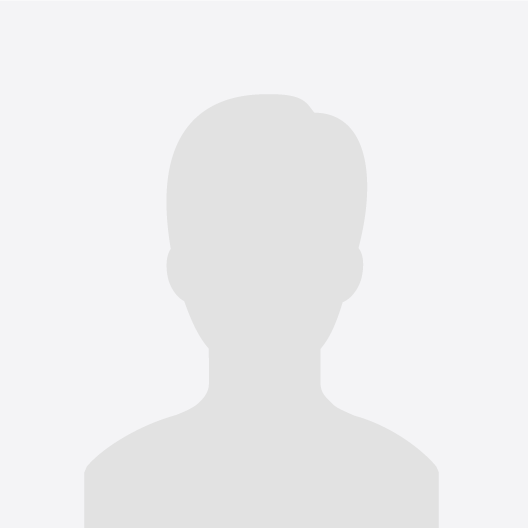Il multiculturalismo è ormai da quasi cinquant’anni argomento di discussione pubblica e politica, nonché oggetto di studio nel mondo accademico. Nell’ultimo decennio però, da formula corretta ed efficace per affrontare i problemi nati a seguito dei grandi processi migratori, le politiche multiculturali hanno gradualmente perso consensi tra molti leader politici e commentatori. Sicuramente la semplice etichetta ‘multiculturale’ non è più sufficiente per gettare luce sulla convivenza tra culture diverse, tra armonia e tensioni.
“Da un lato si tende semplicemente a dare per scontato che il multiculturalismo australiano sia una storia di successi, senza andare molto oltre. Dall’altro, sebbene una buona parte della società ne faccia un punto di orgoglio nazionale, basta grattare sotto la superficie per scoprire che c’è ancora una mentalità aggressiva o razzista nei confronti del ‘diverso’”, spiega Daniella Trimboli, ricercatrice presso l’Institute for Citizenship and Globalisation della Deakin University.
Nel suo libro Mediating Multiculturalism - Digital Storytelling and the Everyday Ethnic, pubblicato il mese scorso da Anthem Press, Daniella esplora il genere del “digital storytelling”, ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali, per mettere in luce tali dissonanze nelle storie d’immigrazione.
“Il digital storytelling è un genere emerso nei primi anni 2000: sono brevi video-storie raccontate in prima persona, della durata di pochi minuti, piccoli condensati di vita di gente comune. Sono considerate forme di autoespressione molto accessibili attraverso cui condividere la propria storia. A un certo punto della mia ricerca ho deciso di analizzare la collezione di video-storie sull’immigrazione curata dall’ACMI. Molti filmati arrivavano dalla comunità arabo-australiana, come risposta al crescente sentimento anti-islamico di quegli anni, emerso anche negli scontri di Cronulla. Mi ha colpito subito il fatto che i racconti seguivano tutti lo stesso modello, la stessa parabola: dalle difficoltà e fatiche iniziali a un presente positivo. Questo copione non lasciava spazio a nessun tipo di sfumatura, appiattendo in qualche modo l’esperienza della migrazione, per arrivare in pochi minuti al lieto fine. La stessa tendenza si può riscontrare nel dibattito pubblico sul multiculturalismo australiano, che tende a glissare sulle esperienze vere di differenza culturale”.
Nell’archivio dell’ACMI, Daniella si è imbattuta nella serie intitolata “Racconti: La voce del popolo”, i cui protagonisti sono tutti di origine italiana. In particolare Per amore e per forza, il filmato con la storia del compianto Giovanni Sgrò, l’ex parlamentare del Victoria, fondatore assieme ad altri connazionali della FILEF (Federazione Italiana Lavoratori Emigrati e Famiglie), nonché uno degli organizzatori delle sommosse di Bonegilla.
“Il suo video-racconto è uno dei pochi che riporta in primo piano quella tensione del migrante. Forse ora le nuove generazioni si sentono più accettate dalla società o forse hanno dimenticato quelle esperienze iniziali. Spesso mi sento ripetere: ‘Ora tocca ai nuovi immigrati’. Quindi non abbiamo imparato niente! Dovremmo riflettere sul passato per far sì che questi meccanismi non si ripetano”.
Daniella avrebbe dovuto presentare il suo libro presso l’Institute of Postcolonial Studies di North Melbourne, ma date le attuali restrizioni ha optato invece per un annuncio online sulla sua pagina Facebook, preceduto da un ringraziamento in dialettto calabrese, una scelta dettata da più di un motivo.
“Nella mia famiglia i dialetti sono sempre stati parte del nostro quotidiano. Mia mamma è scozzese e spesso usava termini dialettali, mentre mio padre è calabrese. L’uso di una lingua minoritaria in un contesto dove l’inglese è l’idioma imperante è un modo per mettere tale egemonia in discussione. Inoltre, le donne del ramo paterno della mia famiglia sono sempre state una fonte d’ispirazione per me e ho voluto dedicare a loro i miei risultati accademici.”