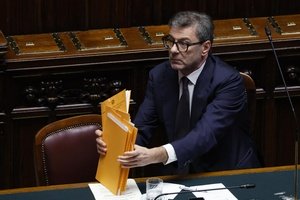A breve distanza navigava Necessary Evil, un’altra fortezza volante, con l’incarico di documentare il primo bombardamento nucleare della storia. Dai suoi oblò venne immortalato il fungo radioattivo che, pochi minuti dopo, si innalzava su Hiroshima. Tre giorni dopo fu la volta di Fat Guy, che rase al suolo Nagasaki. Oggi, negli USA, quel nomignolo sarebbe forse considerato irriguardoso nei confronti delle persone sovrappeso e sarebbe necessario inventarne uno “politicamente corretto”. Ad ogni modo, le due bombe avevano cariche diverse, l’una all’uranio e l’altra al plutonio, quindi fu necessario sperimentarle entrambe. Sulla conta dei morti non si è mai giunti a un dato certo, ma furono molti di più di quelli che gli scienziati avevano previsto. Un vero successo militare, con una punta di amaro: a Hiroshima rimasero polverizzati anche dodici giovani americani. Dodici prigionieri di guerra uccisi da fuoco amico. Nel memoriale per la pace che sorge oggi nella città giapponese il governo degli Stati Uniti ha collocato una targa, per ricordare il sacrificio di quei dodici. Solo quelli hanno trovato posto nella loro contabilità.
Dei tanti che resero possibile l’atomica è rimasto solo qualche nome nella memoria collettiva: Truman, il presidente; Oppenheimer, il fisico; Tibbets, il pilota. Altri protagonisti di quella storia non sono mai entrati nella sua narrativa. Non li incontriamo nemmeno nel recente film di Christopher Nolan, record di incassi. Nessuno ha mai raccontato, ad esempio, dei minatori congolesi che estrassero dalle viscere della terra il minerale necessario all’impresa. Nel film vediamo un contenitore di vetro nel quale, di tanto in tanto, vengono aggiunte delle pietruzze; uno stratagemma usato per simboleggiare la quantità crescente di uranio a disposizione del progetto. Solo quando il recipiente sarà pieno si avrà la massa critica necessaria ad innescare la reazione nucleare. Non si vedono però le miniere di Shinkolobwe, dove minatori che un tempo erano stati gli schiavi personali del feroce re Leopoldo II e poi erano diventati sudditi del Belgio, lavorarono fino allo sfinimento, costretti a turni massacranti per alimentare lo sforzo bellico dei loro persecutori. Senza di loro le bombe sarebbero stati due inutili gusci di acciaio, eppure nulla sappiamo del loro destino, quante frustate furono loro assestate e se poi morirono infettati dalle radiazioni. Nessuna targa ricorda il loro sacrificio. Per loro non furono costruite abitazioni confortevoli, come per gli scienziati, né fu loro concessa la vicinanza delle famiglie.
La storiografia ufficiale americana sostiene che i bombardamenti atomici posero fine alla guerra nel Pacifico, salvando molte vite. Storici di altri paesi ritengono invece che a convincere il Giappone alla resa sia stata la dichiarazione di guerra da parte dell’Unione Sovietica. Sia come sia, quelle bombe, mentre concludevano in una strage la Seconda guerra mondiale, inauguravano già il dopoguerra e nel film aleggia la cupa atmosfera della guerra fredda, quando in Occidente la paura per il comunismo superava quella per il nazifascismo. Gli hibakusha, i sopravvissuti all’olocausto nucleare, restano invece sullo sfondo, appena percettibili, come fantasmi di carta nei sogni turbati del protagonista, scacciati con fastidio dal presidente, che aveva presentato la bomba al mondo come un dono di Dio all’America. Di quei superstiti, bruciati dentro dal fuoco radioattivo, non si parla.
Per saperne qualcosa conviene allora guardare un vecchio documentario della BBC, realizzato nel sessantesimo anniversario della bomba. Pochi soldi e nessun effetto speciale ma lì, almeno, gli hibakusha ci sono e parlano. Raccontano il tormento di chi si trovò nel cuore infernale dell’esplosione e si salvò, per poi vivere una vita dannata. Ci sono anche le interviste ai piloti che la bomba l’avevano sganciata e sono testimonianze impressionanti: “Non ho rimorsi, né rimpianti, dormo da sempre sonni tranquilli. Ero un aviere che doveva colpire il suo target e ho compiuto il mio dovere. Non era compito mio preoccuparmi della moralità delle azioni che mi venivano ordinate”. Parola di Paul Tibbets, il pilota di Enola Gay, comandante della missione su Hiroshima. Lui stesso aveva dato al velivolo il nome della mamma. Chissà se lei ne fu felice. Si è spento a 92 anni, circondato dall’affetto dei suoi. Nessuna ombra sulla coscienza, fino alla fine, nessun ripensamento.
Nel documentario si racconta anche un’altra storia, rimasta a lungo sepolta fra i segreti di stato: a partire dal settembre 1945 gli USA inviarono team medici nelle due città bombardate. I sopravvissuti, vedendosi intervistati e visitati da personale sanitario, si aspettavano cure e rimedi, però quei medici non erano lì per curare ma per studiare gli effetti delle radiazioni. La conta delle malattie genetiche, dei tumori e dei bambini mostruosi partoriti da donne disperate riempirà, negli anni seguenti, gli studi di statistica e i manuali di strategia militare.
Lo studio degli effetti devastanti delle radiazioni avrebbe dovuto convincere gli strateghi ad abbandonare l’uso del nucleare per scopi militari. Invece gli esperimenti si moltiplicarono, anche al prezzo di intere popolazioni deportate e delle loro case contaminate per secoli a venire. Armi atomiche di potenza insensata riempirono gli arsenali, fino a rendere possibile annientare molte volte la vita sulla Terra, giustificando quell’escalation con la terrificante teoria della deterrenza. Per decenni abbiamo rischiato l’Armageddon, per errore umano, decisione strategica, capriccio del destino o follia. Quella spada di Damocle pende ancora sulle nostre teste e quasi non ne siamo consapevoli.
Oggi la bomba la possiedono in tanti e la presunta volontà di Dio non sembra più così cristallina come apparve a Truman. Quegli scienziati ci hanno lasciato in eredità la possibilità di un’apocalisse senza redenzione. Nel film li vediamo esultare, perché la bomba ha funzionato, ma oggi sappiamo che tutti potremmo diventare vittime dell’olocausto nucleare o, peggio, hibakusha, in un mondo spento. C’è davvero poco da festeggiare.