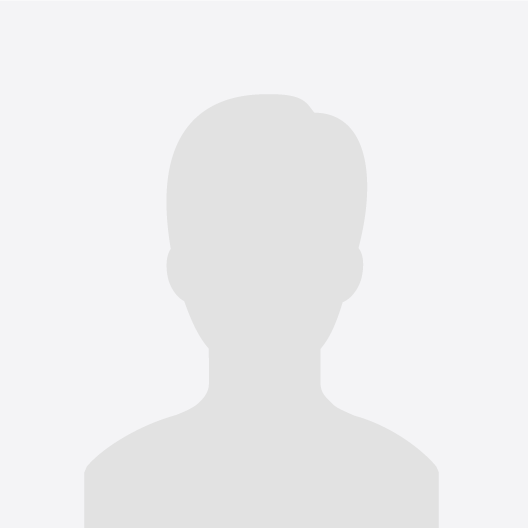La mia ammirazione oggi va alla russa Elena Popova, all’ucraino Yuri Sheliazhenko, al “refusenik” israeliano Shlomo: obiettori di coscienza, perseguitati dalle rispettive autorità e additati al pubblico come disprezzabili esempi di viltà. Gente che ha rifiutato la violenza e cerca il dialogo col nemico, vero o presunto che sia.
“Le perquisizioni mi spaventano – racconta la Popova –: entrano in casa, sequestrano tutto, ogni giorno vengono arrestate persone, ma penso agli amici ucraini sotto le bombe, penso a chi sta perdendo la casa e i propri cari e devo continuare a lavorare per la pace”.
“Pace e solidarietà comportano la necessità di un cessate il fuoco immediato e di colloqui di pace globali – dice Sheliazhenko –. Viviamo tutti sullo stesso pianeta e dobbiamo trovare una soluzione comune, abbiamo bisogno di costruire una società nonviolenta, senza nemici e senza frontiere”.
Da un carcere militare Shlomo ringrazia chi approva il suo rifiuto di sparare sui palestinesi e sostiene: “Questo conflitto non sarà risolto con la guerra e la morte; avremo pace solo attraverso la comprensione e l’empatia”.
Ammiro anche gli storici, quando non sono schierati con le narrazioni ufficiali e vanno a scovare la verità negli archivi, rendendo un grande servizio alla verità. Penso a Henry Reynolds che ha studiato le persecuzioni subite dagli aborigeni in Australia, alle indagini di Giorgio Dal Boca sugli orrori del colonialismo italiano, agli studi di Howard Zinn sulla storia degli Stati Uniti o alle analisi di James Lowen, che ha messo a nudo molte ipocrisie dei testi di storia americani in un saggio intitolato, Le bugie che il professore di storia mi ha raccontato. Penso allo storico israeliano Ilan Pappé, denigrato dalle autorità del suo Paese perché ha messo a nudo le ambiguità del sionismo, smantellando la mitologia fondativa dello Stato di Israele. Pappé ha riassunto queste sue ricerche in un breve saggio divulgativo intitolato, 10 miti su Israele: dieci capitoli nei quali rivela il castello ideologico su cui i governi israeliani basano la moralità delle loro azioni immorali.
Le recenti rivelazioni del New York Times sulla strage deliberata di un’équipe medica disarmata, a Gaza, con il filmato realizzato da un infermiere poco prima di essere brutalmente assassinato, smantella l’undicesimo mito: quello della superiorità morale dell’esercito israeliano. Racconta Shlomo: “Crescendo in un insediamento ebraico in Cisgiordania, la mia comunità mi ha insegnato che l’esercito israeliano è il più morale al mondo, diverso da qualsiasi altro esercito che pratica la guerra”. Una convinzione che ho ascoltato anche dalla voce di alcuni miei amici e parenti, ebrei romani, che sono cresciuti con questa incrollabile convinzione, frutto evidente di indottrinamento.
Shlomo, dopo l’arruolamento, ha dovuto fare i conti con la realtà, come accade anche a tanti soldati americani che, alla prima licenza, disertano e riparano in Canada, disgustati da quello che sono stati costretti a fare. Dopo le rivelazioni dell’autorevole quotidiano l’esercito israeliano non potrà più rivendicare la sua presunta superiorità morale: è un esercito che uccide brutalmente innocenti indifesi, come fanno tutti gli eserciti, a dimostrazione che, per quante buone ragioni si possano avere, non sarà mai la guerra a portare una vera pace.
La via della pace è sempre disarmata, sostiene la sociologa Erella Shadmi, anche lei ebrea israeliana. Nel recente saggio, Una pace possibile, scrive: “La pace non è l’atto conclusivo di una guerra, ma il modo in cui trattiamo i nostri simili, il modo in cui ci trattiamo nella vita di ogni giorno, è il nostro stile di vita quotidiano, che scegliamo di applicare in ogni istante. Tutto ciò che dobbiamo fare è tradurre le nostre azioni quotidiane in una società di pace, abbandonando l’alienazione e la solitudine in cui viviamo e scegliendo una vita di cooperazione, di rapporti, di vicinanza, di cura e di responsabilità, considerando il mondo intero come una casa, come una famiglia capace di contenere tutti gli uomini e le donne attorno a noi, compresa l’accettazione degli stranieri e dei nemici come membri della stessa famiglia. Tutto ciò che dobbiamo fare è tradurre le nostre azioni quotidiane in una società di pace”. In quella Terrasanta martoriata queste parole sembrano talmente ingenue da apparire folli, eppure sono anche terribilmente indispensabili.
È così lampante: da decenni, in quella regione tutto laggiù è fatto di armi che tuonano, rabbia, persecuzioni, risposte violente e firma di accordi che nessuno ha mai rispettato e che non hanno mai portato da nessuna parte, perché non si voleva che approdassero veramente a un risultato. Se si analizza la realtà alla luce di questa semplice constatazione diventa fin troppo chiaro che la Shadmi ha ragione, quando indica la necessità di un cambio di coscienza e sprona la sua gente, ebrei e arabi di Israele, credenti e non credenti, a guardare alla possibilità della pace da un altro punto di vista, uno al quale, sono le sue parole: “Non siamo ancora abituati”.
Ciò a cui pensa la sociologa è la fondazione di una “società del dono”, con valori alternativi a quelli “occidentali” che hanno portato al disastro armato ed è proprio nell’unicità della storia ebraica, in quel modo particolare che ha il popolo ebreo di fare comunità, che la Shadmi individua una fonte autorevole di ispirazione.
In questa visione la società da costruire perde le sue caratteristiche etniche e si basa su una profonda amicizia tra gruppi che possono anche mantenere le proprie caratteristiche ma nel rispetto delle peculiarità altrui. La Shadmi, come altri intellettuali israeliani, rifiuta la narrazione di “due popoli, due Stati” e vede il futuro in un’unica comunità che metta da parte storia e ambizioni per costruire nuovi legami. Questa è, per questa sociologa femminista, la via della pace possibile.
È chiaramente poco più di un sogno, ma in quel sogno ritrovo una speranza che ho visto persa negli occhi terrorizzati di quel giovane infermiere che, poco prima di essere assassinato, chiedeva perdono alla madre, perché perdeva la vita per aver scelto di aiutare gli altri.
stravagario.aladino@gmail.com