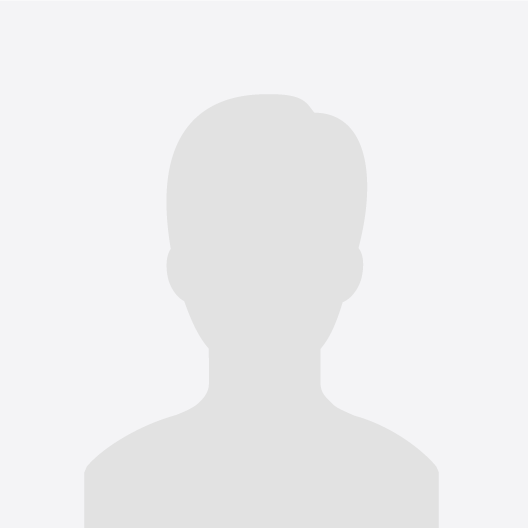LIONE - Cosa resta di Dante oggi, a sette secoli dalla sua morte? Qual è la sua eredità, oltre il culto accademico e le ricorrenze istituzionali? E soprattutto: in che modo può ancora parlare ai giovani, ai lettori e alle lettrici del XXI secolo, a chi lo incontra per la prima volta tra i banchi di scuola o magari in un videogioco? È da queste domande che si sviluppa la riflessione alla base della Seconda Giornata dell’Italianismo – Dante e Noi, tenutasi il 26 marzo scorso presso l’Université Clermont Auvergne.
Un evento che ha riunito insegnanti-ricercatori, studenti, scrittrici e ospiti accademici da varie università francesi per un’intera giornata di studio, scambio e laboratori didattici dedicati al poeta fiorentino, ma con uno sguardo spiccatamente contemporaneo e multidisciplinare.
Che Dante Alighieri sia una figura centrale nel patrimonio culturale dell’umanità non è certo una novità. Ma la sua presenza nella cultura popolare, spesso ignorata o sottovalutata, è più viva che mai. Dall’inquietante Dante’s Inferno – videogioco che trasforma la discesa agli Inferi in un’epopea d’azione tra mostri e dannati – alla saga Devil May Cry, che prende in prestito nomi, suggestioni e atmosfere dalla Commedia, fino alla sua trasposizione nei fumetti, nelle fan-fiction e persino nei manga giapponesi, Dante continua a essere un generatore potente di simboli e immaginari. È proprio da questa dimensione pop, trasversale, che la Giornata ha scelto di partire, per mostrare quanto e come il poeta parli ancora alla nostra epoca, anche – e forse soprattutto – fuori dai confini dell’accademia.
L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione dopo il debutto nel 2024 dedicato a Le donne tra innovazione e resistenza, è nata dall’idea delle docenti Donatella Bisconti e Irene Cacopardi, in sinergia con il Dipartimento di Italianistica dell’università e con l'Istituto Italiano di Cultura di Lione. Come raccontano le due ricercatrici, la Giornata è frutto di un’esigenza sia didattica che culturale. “Dei colleghi lusofoni avevano cominciato a organizzare eventi simili sul portoghese, e ci siamo dette: perché non farlo anche noi?”, spiega Donatella Bisconti, docente ordinaria e specialista di letteratura medievale.
Ma c’è anche un altro motivo, forse più urgente: “La volontà di promuovere la lingua e la cultura italiana in un contesto accademico dove le iscrizioni, oggi, sono in calo”, sottolinea Cacopardi.
Il tema di quest’anno, Dante e Noi, è stato scelto con cura: un titolo che suggerisce prossimità, riflessione condivisa, rilettura. L’obiettivo era chiaro: svecchiare l’immagine del poeta e renderlo accessibile, anche a studenti non italofoni che, nella maggior parte dei casi, conoscono solo superficialmente la Commedia. Per farlo, le docenti hanno deciso di concentrare l’attenzione sull’Inferno, la cantica più scenica e drammatica, quella più presente nell’immaginario moderno. “È la parte più movimentata, con i personaggi più grotteschi, spaventosi e cattivi”, osserva Bisconti. “Non a caso è quella più frequentemente ripresa e reinterpretata nei media contemporanei”.
 Un momento della giornata.
Un momento della giornata.
Durante la giornata, tre relatori – Giuseppe Sangirardi (Université de Lorraine), Chiara Zambelli (Université Grenoble-Alpes) e Alessandro Benucci (Université Paris-Nanterre) – hanno offerto letture differenti della figura di Dante: dal Dante risorgimentale evocato dai prigionieri di guerra, al Dante delle trasposizioni letterarie e visive. Momento centrale è stata poi la proiezione del film Dante di Pupi Avati, accompagnata da un intervento del regista in videocollegamento. “Gli studenti hanno preparato delle domande, che gli hanno poi rivolto direttamente”, racconta Bisconti. Ma la vera forza dell’iniziativa non è stata solo nella qualità degli interventi, quanto nel coinvolgimento diretto e profondo del corpo studentesco.
Gli studenti e le studentesse, infatti, non sono stati semplici spettatori. Per settimane hanno lavorato all’organizzazione dell’evento: dalla lettura di articoli scientifici in lingua italiana – spesso complessi e tecnici – alla preparazione di workshop tematici, fino alla gestione della comunicazione e degli invitati. “Ho cercato di dimostrare due cose”, afferma Bisconti. “Da un lato, l’aspetto umano di Dante, esule, perseguitato, uomo che ha perso tutto. Un’esperienza che risuona drammaticamente con la nostra attualità. Dall’altro, i suoi ideali di giustizia e pace, valori ancora fondativi per la nostra vita collettiva”.
Un’attenzione particolare è stata riservata all’aspetto pedagogico e alla dimensione della mediazione culturale, su cui si è concentrato il lavoro della professoressa Cacopardi. “Abbiamo lavorato sul contenuto e sulla sua trasmissione”, spiega. “Gli studenti si sono confrontati con scritti accademici su Dante pop, Dante trash, cercando di capire come una cultura alta possa essere rielaborata, reinvestita e trasmessa in modi diversi. L’obiettivo era anche quello di formare una consapevolezza critica su cosa significhi trattare temi scientifici e riproporli in chiave divulgativa”.
Il risultato è stato sorprendente: una generazione di studenti che ha riscoperto Dante non solo come oggetto di studio, ma come strumento per leggere il presente. Le trasposizioni pop, da cui la Giornata ha preso spunto, non sono state usate come semplice attrazione, ma come leva didattica per interrogare i significati profondi dell’opera dantesca e renderli vivi. In questo senso, Dante e Noi è stata una vera operazione di “mediazione creativa”, capace di saldare il rigore accademico con l’inventiva della cultura popolare.
L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di rinnovamento didattico, in cui l’università cerca nuove strade per coinvolgere e formare studenti globali, capaci di muoversi tra lingue, media e discipline. E Dante, con la sua voce inimitabile e le sue infinite reincarnazioni, sembra essere ancora una guida preziosa per attraversare i nostri labirinti quotidiani.